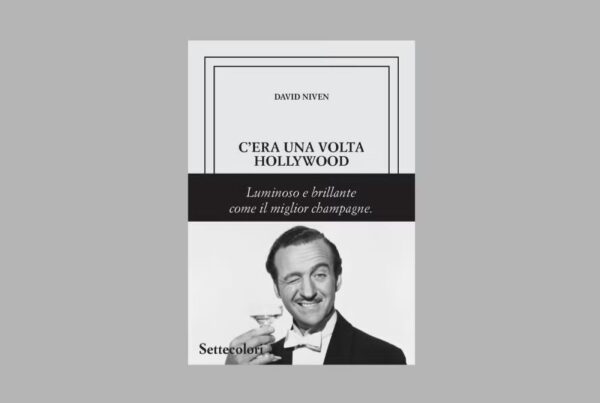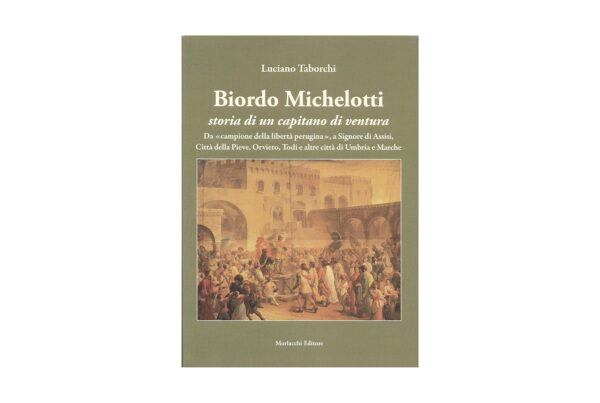di Daniela Motronola
Personalmente, lo ammetto, sono una tifosa sfegatata della forma racconto. Ritengo anzi il racconto superiore al romanzo perché più insidioso. Più bisognoso di ritmo di sintesi e per paradosso di vastità di visione. Il racconto poi ha una tradizione sterminata, diversamente da quanto si creda. Una miope critica, che creda si possa far risalire il racconto a pur grandi maestri come Edgar Allan Poe e Sherwood Anderson (cioè l’Ottocento americano) e continuando nella stessa scia rimbalzi agli anni Ottanta del Novecento (con Carver e Leavitt per esempio), incorre nell’errore classico di non prendere in considerazione nessun altro Paese, nello stesso continente come nel resto del mondo, e di non vedere la lunga fila di sassolini luminosi che permette di risalire comodamente al Duecento italiano.
La dote massima che mi sento di riconoscere al racconto è la libertà. E l’ossessione. Due movimenti opposti.
La libertà consiste nella varietà di tematiche ambientazioni e personaggi. L’ossessione nel seguire un filo invisibile e tenace che a un certo punto emerge e appare nitidamente pur in tanta diversità poetica.
Mi sembra che queste qualità siano tutte presenti nella raccolta Inverness (interzona, 174 pagine, 15 Euro) in cui Monica Pareschi [gloriosa traduttrice di grandi autori, tra cui alcuni classici (da Emily Brontë a Thomas Hardy) e contemporanei di gran vaglia (su tutti Claire Keegan)], in cinquina al Premio Campiello 2025, ci immerge nel gelo e nel blocco di una condizione, comune alle sette storie qui raccolte, che consiste in una specie di mutismo interiore, una condizione invernale dell’animo che forse può farci tornare in mente Un cuore in inverno, e il volto immobile per la deprivazione interiore di Daniel Auteuil in quel (ormai) vecchio film.
C’è qui una differenza non irrilevante (per litote sempre è opportuno dare utili segnalazioni): prevalgono le figure femminili. L’inverno dello scontento esistenziale di questi personaggi, perlopiù donne, sonda diverse età e situazioni, in cui (in tutte, immancabilmente) emergono due elementi: il punto di vista e il distacco.
Alla base, una feroce ironia, un senso del paradosso, una latenza pericolosa verso il grottesco (o diabolico, nel senso di disumano poiché forse troppo umano, dunque vulnerabile corruttibile violentabile, e violento).
Il punto alfa della racconta è I BACI DI MUNCH, O LA PERFEZIONE DELL’AMORE: un racconto folgorante che gioca, linguisticamente, sul significato della parola BACIO. Non solo da intendersi come incontro di labbra e, direbbero Nuti/Veronesi, rifrullo: la lingua che esplora la bocca dell’altro e lo assapora, lo gusta, facendosi a sua volta assaporare e gustare. Ma anche, soprattutto, la cronaca della prima volta con tutto il suo bravo corredo di scomodità asperità impurezza violazione. So che questa porta d’ingresso al libro ha diviso lettori e lettrici, a cui mi permetto di ricordare sempre che trattasi di letteratura: non di pura cronaca realistica ma di elaborazione e soprattutto trasformazione simbolica e impressionistica.
Grande impressione, infatti. E questa reazione permane nel corso della lettura di tutto il libro.
Giù giù fino al racconto finale, il punto òmega della raccolta, Inverness, da cui il titolo generale.
Qui, come acquisizione finale, scopriamo non solo che il nome della località scozzese, nota per il Lago di Ness (Lochness) e per la cara Nessie, è la meta ipotetica di un viaggio in autostop di due ragazze, amiche, incaponite a risalire la Gran Bretagna, da cui emergeranno tutte le differenze tra loro e un senso invadente di eccesso di affezione, ma emerge il senso dell’intera raccolta, intenta appunto, pur senza darlo a vedere, a indicarci la qualità invernale dell’umanità raccolta in questi racconti, l’inattendibile ambiguità di questo pugno di persone dotate di una loro spietatezza quasi innocente. C’è anzi un’acme bulgakoviana in un personaggio, Gheri (chiamato così per una somiglianza, pare notata da tutti, con Gary Cooper, l’attore), il quale finisce come Berlioz (ricordate Il Maestro e Margherita?), non con la testa tagliata dal tram ma a suo modo inchiodato ai binari dell’esistenza che gli ha dato continue avvisaglie terminali regolarmente ignorate per fare posto a una incerta sbruffoneria maschile – anche qui si può invocare dopotutto il karma.
Poi si viene come sempre assaliti dalla memoria, così, sinistramente, quel nome, Gheri, ripesca il nome di Gherasim, il contadino che è l’unico ad accudire Ivan Il’ic mentre stenta a morire nell’omonimo romanzo breve o racconto lungo di Lev Tolstoj, tradotto da Tommaso Landolfi, mirabile raccontatore e russista.
Si diceva il punto di vista e il distacco. Aggiungerei la limpidezza di visione. Che accresce e rivela la sporcizia. La crudezza della vita vera. L’impossibilità di ogni illusione. La coltivazione di sogni destinata alla smentita.
La poetica del libro sta tutta in questo amor di verità che, pure, non mette a tacere il desiderio. I desideri.
Direte: Lacan. Restiamo invece in ambito letterario. E restiamo in una piega, altri direbbe deriva, realistica che ha segnato per esempio un esordio notevole, però nel romanzo, Nata nell’acqua sporca di G. Vitali (ne abbiamo scritto di recente proprio in questo spazio). Qual è il punto di contatto? E si tratta di due autrici molto diverse, diverse in tutto, soprattutto per età e carriera. Il punto di contatto è una visione senza veli: rimosso completamente il velo di Maya di schopenhaueriana memoria: nessuna illusione, nessun balsamo, nessuna zuccherina edulcorazione, la realtà svelata senza remore nella sua crudezza, e con animo duro, con disillusione totale, senza appigli a risorse romantiche, senza sentimentalismi, per cui la vertigine che deriva da questi quadri espressionisti che ritraggono direttamente il vero sentire non dà luogo a letteratura come ornamento, a poesia nell’accezione che dà, non ricordo più se in Ex cattedra o in Fuori Registro, un preside già dirigente in pectore rivolgendosi all’alter ego di Domenico Starnone: “Professore, non mi faccia poesia!” ma invia chi legge – poiché questo in origine fa chi scrive – a una versione spassionata, quasi da reportage, se non usassero, Vitali come Pareschi, come terreno comune, squisite risorse comprovatamente narrative.
In qualche intervista recente, Monica Pareschi ha invocato come nume tutelare proprio Tommaso Landolfi, maestro del grottesco, e però è questo il passo avanti, la frazione ulteriore conquistata da Pareschi nella staffetta letteraria: Landolfi era ancora eufuista e barocco, l’autrice di Inverness ci offre una letteratura senza cascami … letterari, e curiosamente (è paradossale, dopotutto) ironica. Non umoristica né comica. Dolente invece e seria. Intenta com’è a ritrarre l’amor proprio: l’integrità individuale, insidiata di continuo, e proterva anche nel contro-insidiare: People stare at you, they stare a lot – diceva in una intervista semi-seria Rowan Atkinson (l’attore che interpreta Mr. Bean) riferendosi a chi lo incrocia e non è sicuro se lo riconosca o no, La gente ti fissa, fissano un sacco: accade qui tra due amiche lanciate in uno strano viaggio che, come quando si va in barca senza troppo ragionare sull’equipaggio, rivela quanto poco amiche siano. Un dato in termini di tematica letteraria, quindi di poetica, assolutamente contemporanea, direi istantanea.