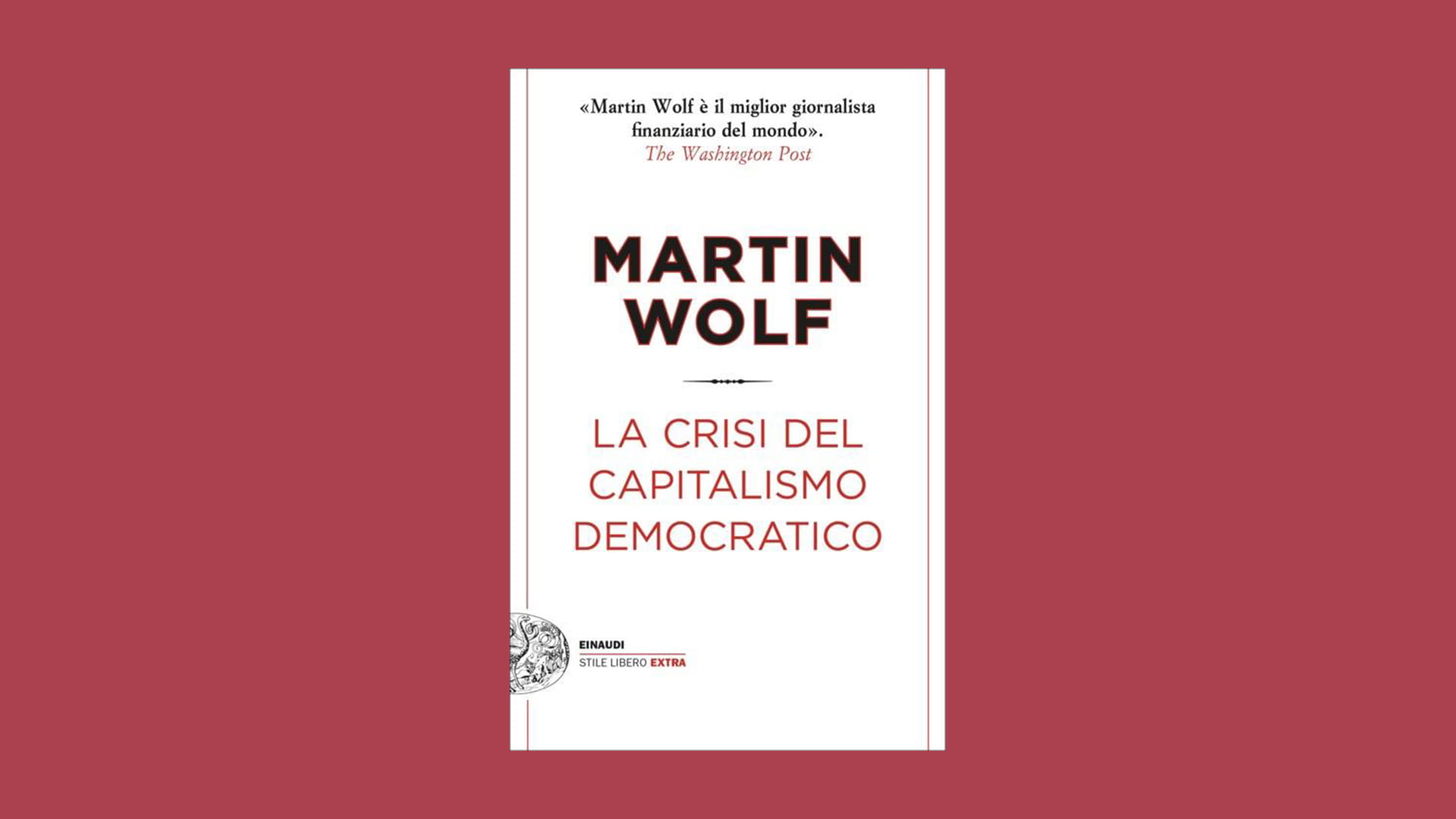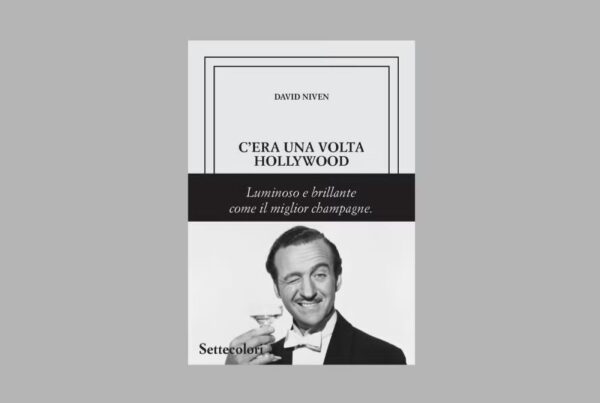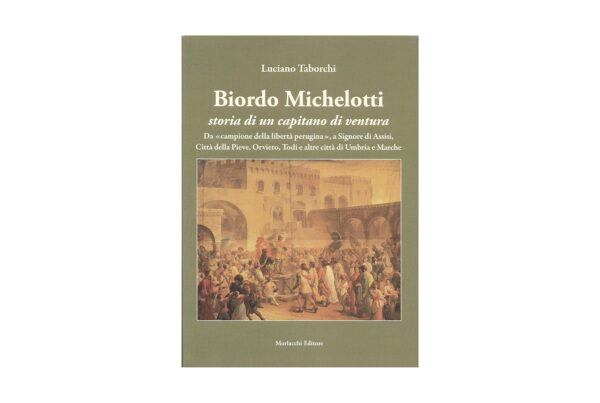Inauguriamo oggi una nuova rubrica col titolo “Il libro”. Già da tempo facciamo delle recensioni, ma abbiamo deciso di accentuare sulla nostra rivista l’attenzione verso i temi e i punti caldi della crisi e di segnalare dunque i libri che li affrontano. Abbiamo scelto di farlo anche dopo aver visto la buona accoglienza che ha avuto il pezzo di Simone Aureli sulla Russia di Putin. Oggi pubblichiamo questa riflessione di Ruggero Ranieri che nasce dalla lettura di “La crisi del capitalismo democratico” di Martin Wolf.
di R. Ranieri | Il libro
Molti sono i libri che ci invitano a riflettere su quello che appare il problema centrale dei nostri giorni: stiamo perdendo la nostra democrazia in favore di forme di autoritarismo più o meno esplicite e dichiarate.
Mi vorrei soffermare su un testo che mi ha particolarmente colpito per la sua profondità e la sua vastezza: è l’ultimo lavoro di Martin Wolf tradotto in italiano con il titolo La crisi del capitalismo democratico [Einaudi, 2025].
Chi è Martin Wolf? È, da molti anni, il più autorevole commentatore economico del Financial Times ed ha prodotto importanti studi sugli eventi degli ultimi decenni, dall’espandersi della globalizzazione, alle crisi finanziarie innescate nel 2008. In questo ultimo volume fa uno sforzo per guardare agli aspetti politici e sociali delle società contemporanee.
Affronta tre aspetti: la definizione di capitalismo democratico; le ragioni della crisi attuale contrassegnata dall’emergere di forze populiste e infine alcune prescrizioni possibili per salvare la democrazia. Il libro, che pure è ispirato a un drammatico giudizio sulle tendenze attuali, è stato scritto prima dell’avvento della presidenza Trump e suona, così, ancora di più come monito e campanello d’allarme.
Il concetto di capitalismo democratico richiede una certa attenzione. Abituati a ragionare per categorie ideologiche otto o novecentesche, i due termini sono generalmente posti in qualche forma di discordanza e contraddizione. Wolf parte da una posizione diversa: le società che si sono affermate, non solo in Occidente, durante il Novecento, e soprattutto dal 1945 sono appunto fondate sul binomio capitalismo- democrazia. Il primo garantisce la rottura delle posizioni acquisite e delle barriere sociali, libertà di intraprendere e di innovare; la seconda molto semplicemente che chi governa sia soggetto alla legittimazione popolare, tramite l’universalità del suffragio e libere elezioni e che ci sia stato diritto e imparzialità della legge.
Il fatto è che, almeno fino a oggi, tutte le democrazie liberali stabili hanno ricche economie di mercato, mentre le economie di successo sono tutte, o quasi tutte, democrazie liberali. Sono società che possiamo definire di capitalismo democratico. “Secondo quasi ogni parametro, aspettativa di vita, standard di istruzione, avvicinamento alla parità di diritti, le democrazie a reddito alto sono le società di maggior successo della storia umana. La libertà che offrono, combinata al rifiuto dello status ascritto, favoriscono il progresso tanto degli individui quanto della società.”
Tutto ciò è vero, o era vero fino a poco fa. L’equilibrio fra capitalismo e democrazia è, però, molto fragile. Oggi il capitalismo non è messo in discussione in quanto tale: quasi nessuno caldeggia un’economia pianificata che non dipenda almeno in parte dalle forze di mercato e dalla proprietà privata dei mezzi di produzione, e questo vale anche per regimi non democratici, come per esempio la Cina, la Federazione Russa, molti dei Brics. Ma che tipo di capitalismo ha vinto o vincerà? Un capitalismo democratico, basato sulla competizione e una società libera o un capitalismo autoritario, monopolistico e predatorio?
Per la democrazia il discorso è più semplice: nel corso della storia umana, è stata una eccezione più che una regola. I modelli prevalenti sono stati in qualche modo tirannici o oligarchici. Il fatto che negli ultimi 80/100 anni abbiamo visto, sia pure a ondate, un progressivo allargarsi a molti paesi di istituzioni pienamente democratiche (non basate su un suffragio ristretto come nell’Ottocento) non può essere visto come una regola, ma come una eccezione. Un modello fragile che stiamo già perdendo, se è vero che negli Stati Uniti, che viene reputata la sua culla, alcuni suoi pilastri vengono progressivamente indeboliti.
Il capitalismo democratico non è, quindi, un opzione fra tante, ma è l’unica forma di democrazia possibile, tanto che le maggiori fasi di crescita del capitalismo globale hanno coinciso con le fasi di democratizzazione, come dopo la prima e la seconda guerra mondiale e dopo la caduta del socialismo reale del 1989. D’altra parte le crisi del capitalismo globale stanno determinando un grave arretramento della democrazia.
Capitalismo e democrazia non sono alleati naturali. Il capitalismo può, infatti, preparare il terreno per la democrazia ma può anche finire per distruggerla. Perché funzionino adeguatamente il sistema economico e il sistema politico devono essere non solo separati, ma protetti l’uno dall’altro da istituzioni indipendenti, da norme comunemente accettate e da regole vincolanti. Insomma, nel matrimonio l’uno ha bisogno dell’altra, ma ciascuno deve avere la propria autonomia. I punti chiave sono la separazione fra politica ed economia e l’esistenza di uno stato di diritto. Devono esserci regole chiare e rispettate per un mercato libero e, insieme, deve esserci una condivisione per cui si accetti come legittima la diversità di opinioni e di interessi. Spesso il sistema si configura, quindi, come una “guerra civile” regolamentata.
Se ragioniamo in negativo è facile accorgersi che ove prevalga la politica, chi controlla il governo finisce per controllare anche l’economia: una libera concorrenza diventa impossibile. Si arriva a forme di socialismo di stato, modelli che sono ampiamente falliti. Se invece l’economia prevale sulla politica si arriva a forme di plutocrazia: comandano gli interessi potenti, organizzati in lobby o monopoli, pretendono di controllare le decisioni e le risorse pubbliche. In reazione ci può essere un cavaliere bianco che, fingendosi sganciato dal sistema, può porsi a interprete del popolo schiacciato dalla plutocrazia, accelerando così la degenerazione anti-democratica. È un fenomeno che già Aristotele aveva rimarcato e nel mondo di oggi ne troviamo repliche in abbondanza.
Un ulteriore contraddizione sta nel fatto che il capitalismo democratico non può esistere in una dimensione puramente nazionale. Infatti, il mercato di per se stesso si estende e quindi richiede regole internazionali o forme di collaborazione e di integrazione. È vero altresì che la democrazia si esprime, in primo luogo, a livello nazionale e si appoggia quindi su concetti come identità e cittadinanza. Contemperare questi due livelli non è sempre facile, in quanto l’economia si è internazionalizzata più rapidamente della politica, ma il sovranismo nazionale, agitato dai populisti, è un concetto insufficiente, pericoloso, declinato, come spesso avviene, in forme ridicole e paradossali.
C’è un ultimo aspetto nella riflessione di Wolf che mi piace sottolineare perché è decisivo per capire quanto è avvenuto e può avvenire. Nelle democrazie liberali di cui abbiamo parlato c’è un compromesso fra l’intervento dello stato e il dinamismo del mercato. Il mercato non è contro lo stato ma è con lo Stato; la condizione è che i governi esercitino un ruolo centrale, in tema di concorrenza, istruzione, infrastrutture, ecc. Ma ancora di più se democrazia a suffragio universale e capitalismo devono convivere, rispettandosi, è necessario che la scala dei diritti economici si allarghi, non escluda e quindi dia vita a quella che va sotto il nome di “economia sociale di mercato” o, come la chiama Wolf, “welfare capitalistico”. Questo viene spesso detto semplicemente welfare, con l’errato sottinteso, evocato da forze anticapitaliste, che esso possa essere considerato autonomo dal sistema di capitalismo democratico.
La crisi delle nostre democrazie origina, secondo Wolf, proprio qui: il capitalismo si è irrigidito, ha divorziato dalle sue funzioni sociali, e nello stesso tempo ha cessato di garantire la crescita equilibrata della società. In questo modo si pone sempre più in contraddizione con la democrazia, che a sua volta, indebolendosi, ha preparato una arena favorevole a forze populiste, anti-sistema, prevalentemente di destra. È questo un nuovo capitolo della riflessione che mi riprometto di affrontare.