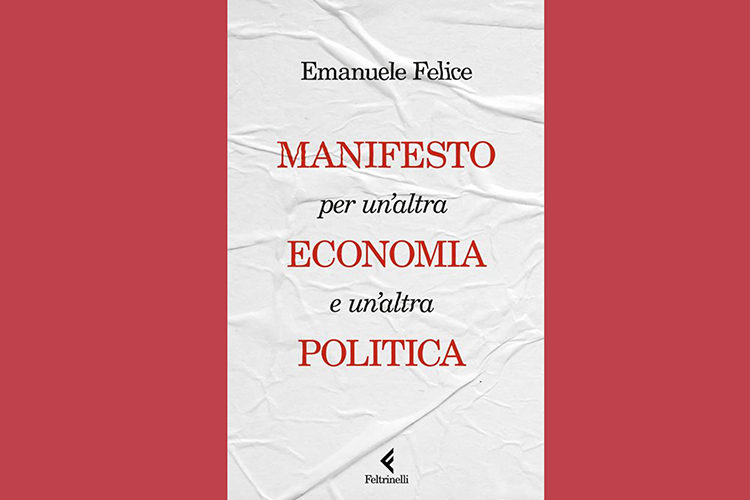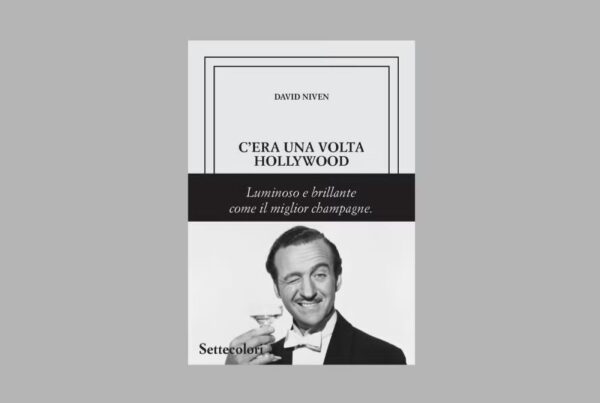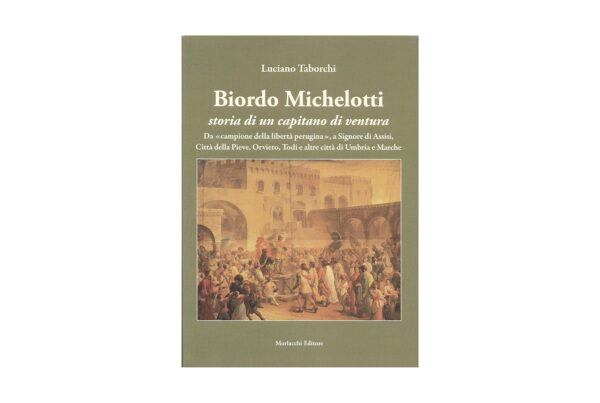di R.Ranieri
Quali sono le azioni e le riforme possibili per difendere le democrazie liberali a regime di mercato di cui abbiamo parlato? Mi appoggio qui non solo all’ illuminane studio di Martin Wolf, ma anche, sia pure in contraddittorio, a un interessante libro di Emanuele Felice, uno storico economico vicino al Partito democratico [Emanuele Felice, Manifesto per un’altra economia e un’altra politica, Feltrinelli, 2025].
Direi che il punto di partenza non può che essere la chiarezza degli obbiettivi. L’equilibrio fra capitalismo e democrazia è fragile ma vitale, alla base delle società di cui vogliamo difendere i valori. È vero che c’è una contraddizione fra il principio egualitario contenuto nel suffragio universale, e la libertà di intraprendere e di arricchirsi del capitalismo, ma è una contraddizione che va composta e governata, non negata. Non è sbagliato riconoscere le distorsioni che filosofie economiche neo-liberali hanno portato e rischiano di portare ancora. Ma assegnare al neo-liberismo una egemonia indiscussa, attribuendogli tutti i difetti delle società democratiche degli ultimi anni, rischia di portarci fuori strada. Al di là del neo-liberismo c’è ancora un capitalismo che crea ricchezza, motore di innovazione e di sviluppo e c’è anche uno stato che continua ad avere un ruolo, può intervenire a indirizzare e cambiare. Il nemico non è, quindi, come crede Felice, il neo-liberismo, quanto il populismo che erode dal di dentro il capitalismo democratico e infatti, come mostrano recenti evoluzioni americane, è pronto a abbracciare indiscriminatamente sia il neoliberismo, sia il mercantilismo o lo statalismo.
Capitalismo “truccato” e errori di Clinton all’origine del populismo
Rimane però la domanda di fondo: come si può reagire? La battaglia giustamente va condotta su due fronti: quello della forma dell’economia e quello del funzionamento della democrazia; su entrambi non partiamo da zero, esiste un catalogo di esperienze e di riforme a cui attingere.
Forse le maggiori difficoltà stanno proprio nella difesa della democrazia, perché ci si può illudere che possa bastare avere, per esempio, un dettato costituzionale rigoroso o garanzie di legge ben formulate, mentre, come confermano molte esperienze, sono elementi che possono essere politicizzati e sovvertiti. Per difendere la democrazia bisogna crederci. I cittadini devono essere sudditi o persone che partecipano alla vita pubblica? Si può immaginare un governo riservato a pochi soggetti? Esiste un sistema che provveda a ricambi del governo e delle élite senza violente scosse o rivoluzioni? La vera difesa sta quindi nelle convinzioni profonde dei cittadini e, al loro interno, soprattutto delle classi dirigenti. Sono questi i soggetti che, agendo insieme e separatamente, hanno il compito e il dovere di sorvegliare la sfera pubblica, il suo corretto funzionamento e i valori democratici.
Tra le tante riforme necessarie al benessere delle democrazie che spaziano dalla lotta alla corruzione, alla necessità di un amministrazione con garanzie di neutralità e di competenza mi sembra che ne emergano con forza due: il concetto di cittadinanza e una informazione libera e trasparente.
La cittadinanza si nutre di patriottismo, che è una cosa diversa dal nazionalismo: è un amore condiviso per il proprio paese e aiuta a tollerare differenze di opinioni e valori al suo interno. È un legame molto importante che integra la fedeltà nei valori costituzionali. Il patriottismo va coniugato, quindi, con doveri civici che la cittadinanza deve incoraggiare. D’altra parte la cittadinanza è fonte di diritti soprattutto in quanto implica un accesso privilegiato alle opportunità offerte da economia e welfare. Questi benefici non possono essere estesi in modo indiscriminato, pena un sentimento di ingiustizia tra large fasce di cittadini, spesso i meno fortunati. È quindi necessario un controllo dei flussi, che sia umano, ma anche accettabile per la maggioranza ed è un limite di intellettuali progressisti e forze di sinistra di non averlo compreso. Il razzismo e la discriminazione contro gli immigrati sostenuto da parte, prevalentemente, dell’estrema destra è latente ed infatti è emerso più volte nella storia, ben prima della sfida populista. Una gestione disinvolta della immigrazione, fornisce, però, ai populisti un combustibile potente.
Un altro capitolo molto importante, che richiede, secondo Wolf, soluzioni coraggiose è quello della informazione. Sono ormai stati ampiamente analizzati gli effetti perversi dei social media il cui scopo principale è generare sempre più traffico online, uniformandosi al modello pubblicitario. Il paradigma che ne deriva è sì la diffusione delle notizie, ma insieme la disinformazione, la ghettizzazione, il complottismo, l’irresponsabilità più totale. E l’intelligenza artificiale, se gestita nello stesso modo, con poche regole e molti ammiccamenti ai grandi produttori, promette scenari anche più pericolosi. In sostanza i nuovi media stanno dando un buon contributo a distruggere la democrazia, che si basava su un opinione pubblica informata e consapevole.
Come si può reagire? Occorre tornare indietro e considerare le grandi imprese che veicolano notizie come editori responsabili in qualche modo di quello che pubblicano. Ci vogliono, quindi, enti di regolazione: come le grandi banche considerate sistemiche sono soggette a regole, così deve essere per i grandi motori di ricerca. Non è necessario arrivare alla soluzione cinese, di un controllo totale della rete, ma le democrazie, pena la loro sopravvivenza non possono tollerare l’anarchia.
Se la democrazia è in pericolo, l’economia è quella che mostra i sintomi di degenerazione più grave. Wolf ne fa un ritratto molto accurato, e su quasi tutti i punti concorda anche Felice. Ci sono fattori che potremmo definire strutturali, in quando risultati di processi consolidati: per esempio instabilità e crisi, drammatiche disuguaglianze sociali, mancanze di opportunità per i ceti medi che hanno visto la fine dell’ascensore sociale. E poi ci sono i problemi più legati alle scelte dei governi e delle imprese: una governance societaria che premia gli insider; un regime concorrenziale che tollera i monopoli; regole soggette a farsi aggirare o corrompere; un sistema fiscale che permette ai plutocrati di pagare le tasse su base pressoché volontaria.
Tra le riforme necessarie, mi limito a sottolinearne due. Innanzitutto la giusta enfasi sul ruolo delle politiche pubbliche, e in particolare su quelle che chiamerei politiche industriali. In molti settori il mercato non basta, investimenti pubblici sono essenziali: per esempio nel campo della scienza e dell’innovazione, per realizzare infrastrutture, proteggere e incentivare la proprietà intellettuale, per l’istruzione e la formazione a tutti i livelli. È giusto sottolineare come lo Stato non debba sostituirsi alle banche e favorire singole imprese e tecnologie specialistiche; questo non significa però che non debba sostenere determinati settori strategici e tecnologie di base. Ugualmente la transizione climatica chiama il settore pubblico a importanti investimenti, senza trascurare sistemi di mercato per ridurre le emissioni. Occorre, comunque, fare attenzione perché una impostazione fatta prevalentemente di divieti e prescrizioni rischia di fare ricadere i costi della riconversione energetica sulle piccole e medie imprese o sui ceti più deboli, aprendo la strada a teorie anti-scientifiche e populiste.
Un secondo punto è il governo della globalizzazione. L’apertura internazionale dell’economa è necessaria, senza però farne un assoluto. I commerci e gli investimenti diretti esteri vanno regolamentati attraverso forme di integrazione e non promossi a scapito di tutto il resto dell’economia. I flussi di capitale a breve termine, invece, generano speculazione e instabilità. Gli accordi internazionali limitano la sovranità dei singoli stati, ma non la cancellano, piuttosto la indirizzano su obbiettivi importanti, proprio perché condivisi.
Senza pretendere di esaurire il tema delle riforme necessarie e possibili per rafforzare, o salvare, il capitalismo democratico (per esempio la tutela del lavoro, il salario minimo, varie forme di indennità e di protezione) è importante alla fine riflettere su quali forze debbano sostenere questo coraggioso programma riformista. Secondo Felice, le cui soluzioni, come abbiamo visto, sono molto radicali e prefigurano una forte limitazione dell’economia di mercato, ci vorrebbe una grande coalizione progressista, che riunisse tutte le forze antagonistiche al sistema. Secondo Wolf, invece, un programma riformista dovrebbe raccogliere il consenso fra destra moderata, centro e sinistra moderata, almeno sugli scopi se non su come definirli e realizzarli. Per difendere le nostre democrazie questa sembra la via maestra, sperando che non sia già troppo tardi e che si possano trovare le energie necessarie, civiche e morali, per opporsi al populismo e ricostruire equilibri di libertà e di sviluppo.