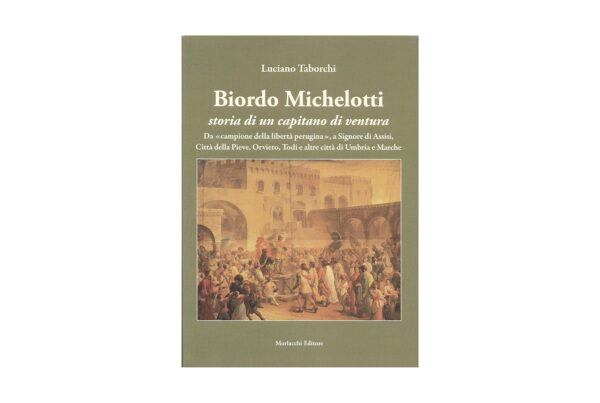di Nicola Fano
Foto ©Gianluca Pantaleo
C’è una scena, nel Riccardo III di Shakespeare messo in scena da Antonio Latella per il Teatro Stabile dell’Umbria, che rivela – io credo – il segno complessivo dello spettacolo e dell’impostazione registica. Qui è l’inizio del secondo tempo, nell’originale è la scena d’apertura del Quarto Atto: Elisabetta (la vedova di Edoardo York, il re di fatto usurpato da Riccardo di Gloucester), Margherita (la vedova di Enrico VI, re Lancaster sconfitto dagli York) e Lady Anna (prima principessa di York poi sposa di Riccardo) parlano tra loro dei rispettivi destini. Tutte e tre sono vittime, sia pure in modo differente, di Riccardo, pure tutte e tre hanno in qualche modo favorito la propria rovina in forza dell’ambizione. O perché non hanno saputo cogliere i contorni della realtà e non hanno creduto in ciò che ciascuna aveva predetto all’altra: la condivisione delle reciproche esperienze non è servita loro a salvarle. È una scena, nell’originale, che si svolge ai piedi della Torre di Londra e non prevede alcuna azione: le donne parlano e le loro parole fanno premio su tutto. Riccardo III è una tragedia di parole, benché l’azione (come sempre in Shakespeare) sia sottesa alle parole stesse, ovvero sia evocata direttamente dalle battute (Shakespeare sapeva ben scatenare l’immaginazione dei suoi spettatori). Ebbene qui le tre donne in qualche modo accordano il proprio corpo con la propria voce: declamano Shakespeare restando immobili perché sia il più possibile chiaro al pubblico ciò che ciascuna dice.
Ecco, lo spettacolo in questione (che ha debuttato al Teatro Morlacchi di Perugia e che ora è in tournée, speriamo una lunga tournée) pone al centro la potenza delle parole di Shakespeare e il sentimento che esse incarnano: la bramosia del male. Il regista, in altri casi ricco di trovate e immagini clamorose, talvolta anche forzate, qui non solo rispetta il dettato dell’autore ma lo esalta alla perfezione. Tanto che sarebbe da consigliare la visione di questo spettacolo in modo specifico a chi (specie tra i più giovani) voglia conoscere Shakespeare e, attraverso di lui, le coordinate della propria eventuale inquietudine; magari violenta.
Una messinscena in un certo senso filologica (grazie anche all’ottima traduzione di Federico Bellini), in quanto s’affida pienamente alla capacità delle parole di Shakespeare di farsi naturalmente spettacolo. Un’operazione non dissimile la tentò qualche anno fa Peter Stein mettendo in scena Riccardo II con Maddalena Crippa nel ruolo del titolo. Ma lì la filologia sconfinava nel tentativo di recuperare anche il (presumibile) stile registico di Shakespeare con il risultato di uno spettacolo colto ma difficilmente godibile da parte di chi non aveva preventivamente studiato le caratteristiche sceniche del teatro elisabettiano (assenza di scenografia, stendardi, costumi variopinti, movimenti ridotti, abbondanza di effetti sonori, nessuna pretesa illuminotecnica). Qui no. Questo di Antonio Latella è uno spettacolo d’oggi: pienamente godibile anche da chi ignora Shakespeare e il suo modo di fare teatro. E questo perché Riccardo III parla a noi contemporanei indagando il piacere del male, il suo banale abisso, mentre Riccardo II (testo sicuramente meno riuscito tra quelli maggiori di Shakespeare) parla di un re intellettuale, un potente inadeguato agli stili del proprio tempo.
Fatta questa lunga premessa, vediamo meglio che cosa ha fatto Latella con i suoi attori: ha lavorato – direi – su tre piani: la costruzione del copione (firmato da lui con il traduttore), l’indirizzo artistico di scene e costumi (firmate rispettivamente da Annelisa Zaccheria e Simona D’Amico), la scelta del cast.
Partiamo da quest’ultimo àmbito: Riccardo III è, nel canone shakespeariano, il testo più breve ma l’unico nel quale il protagonista dice più versi di tutti gli altri personaggi messi insieme. Di datazione incerta (come sempre per Shakespeare), Riccardo III probabilmente è del 1592, con questo testo il giovane autore voleva accreditare il suo amico Richard Burbage come nuovo divo della scena londinese, quindi forzò la mano alle regole del teatro elisabettiano (e quello di sempre) allargando oltre misura il ruolo del protagonista. Ne consegue che chi interpreta – oggi – quel personaggio debba prendere su di sé il peso totale dello spettacolo. Qui Vinicio Marchioni risponde perfettamente a questa necessità: sa essere ambiguo e odioso come Gloucester richiede, ma anche artificiosamente rabbioso o forse sinceramente impaurito di fronte allo stuolo di fantasmi che, nell’ultimo atto, lo condannano. Resterà nella mia memoria di vecchio spettatore, per esempio, la linearità con la quale Vinicio Marchioni passa dall’incubo della paura («Domani nella battaglia pensa a me») al discorso alle truppe (una memorabile tirata razzista degna di un populista d’oggi, per altro) fino alla vacuità della battaglia finale («Un cavallo, il mio regno per un cavallo!»). Una grande prova, dunque: Vinicio Marchioni letteralmente guida la messinscena, imponendo la sua forza interpretativa agli altri interpreti i quali – tutti con grande efficacia – gli rispondono a tono, lasciandosi imbrigliare con bravura nella sua tela e nei suoi ritmi. Tutti meritano di essere ricordati, qui, a cominciare da Giulia Mazzarino che è Lady Anna, ossia la protagonista di una delle più belle scene di teatro mai scritte, quella in cui Riccardo la seduce sul cadavere del marito che le ha appena ucciso. E poi Stefano Patti che fa un Buckingham (fino al sottofinale mellifluo alleato di Riccardo) inedito, solo in apparenza sottotono, piuttosto un furbo per necessità. E tutti gli altri: Silvia Aielli, Anna Coppola, Fabio Capuzzo Dolcetta, Sebastiano Luque Herrera, Luca Ingravalle, Candida Nieri, Annibale Pavone e Andrea Sorrentino.
Scene e costumi, poi, colpiscono, per così dire, in contrasto rispetto al copione: se la storia è nera e terribile, zeppa com’è di sangue e cadaveri, qui tutto avviene in una sorta di giardino dell’eden cosparso di rose bianche (il simbolo degli York) dominato da una enorme tronco cavo e morto, il naturale ricovero di Riccardo il quale in concreto resta in scena per l’intera durata dello spettacolo: due ore e quaranta compreso l’intervallo, un tempo solo nominalmente lungo, giacché il ritmo della messinscena e la potenza delle parole fanno sì che lo spettatore non lo percepisca come tale.
E veniamo al lavoro sul testo. Riccardo III, com’è universalmente noto, racconta l’ascesa al potere di Riccardo di Gloucester dopo la fine della Guerra delle Due Rose combattuta tra York e Lancaster. Per raggiungere il suo obiettivo (sono deforme e inadatto a questi tempi di pace, dice Riccardo nel celeberrimo monologo iniziale di «Ora l’inverno del nostro scontento…»), il terzogenito degli York uccide chiunque si ponga tra sé e il trono: famigliari, nemici, vecchi, giovani, bambini, donne, tutti. Un concentrato di orrori consumati con un sottile godimento, come se si trattasse di una risposta alla propria deformità. In realtà, Shakespeare aveva da accreditare sé stesso presso la corona: egli esagera la realtà storica (ricerche recenti suggeriscono che Riccardo non fosse poi così criminale…) per accrescere il merito di Richmond, il giovane principe che sconfigge il re sanguinario nello scontro conclusivo. Salvo che Richmond, futuro re Enrico VII, altri non è che il fondatore della dinastia Tudor, nonché il nonno della regina Elisabetta I d’Inghilterra, quella cui si deve la meravigliosa stagione teatrale che ha segnato l’umanità tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Ebbene, qui Latella non si occupa né del mito né della realtà storica: piuttosto si affida alla maestria scenica di Shakespeare. Il quale non centrava i suoi testi sulle storie e personaggi ma sui sentimenti. Ogni suo copione è dominato da un modo di sentire interiore: per questo risulta contemporaneo in ogni tempo. Si può tirarlo per la giacca, insomma, purché lo si rispetti. E questo fa Antonio Latella componendo un apologo sul male invento un personaggio “immaginario” (chiamato il Custode) che è un po’ il servo di scena di Riccardo, colui che gli apparecchia gli orrori. La stessa operazione drammaturgica venne compiuta da Richard Loncraine nella sua celebre versione, prima teatrale e poi cinematografica, di Riccardo III con Ian McKellen: lì il servo di scena del male era una dilatazione di un personaggio minore dell’originale, Tyrrel. Insomma, si tratta di una invenzione (quella di Loncraine come quella di Latella e Bellini) in tutto e per tutto interna a Shakespeare. Salvo che qui un colpo di scena finale (che non rivelerò, ovviamente) dà un peso ulteriore al personaggio immaginario: non c’è redenzione, non c’è scappatoia, la storia è un reticolo di male e violenze. Come, del resto, la nostra contemporaneità dimostra ampiamente.