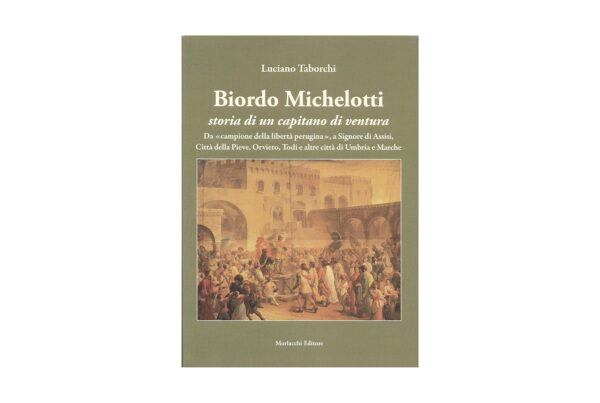di Ida Meneghello
“La morte è niente. Non conta. Me la sono solo svignata nella stanza accanto.”
Sono parole di un canonico anglicano. Ma le stesse parole le ha scritte un gesuita italiano, un poeta francese, vengono attribuite anche a Sant’Agostino.
L’immagine che la morte sia come svignarsela in un’altra stanza, cioè in un’altra dimensione, è un’idea consolatoria che attraversa i secoli e che ha contagiato poeti, filosofi, religiosi. Perciò il titolo del film di Pedro Almodóvar “The room next door” ovvero “La stanza accanto”, primo lungometraggio in lingua inglese del regista spagnolo, meritatamente premiato a Venezia col Leone d’oro, ci suona così familiare, perché abbiamo nella mente proprio questa immagine.
In realtà nel film di Almodóvar la stanza accanto non è la metafora dell’al di là, è lo spazio reale delimitato da pareti dove Martha ha deciso di fare, quando sarà pronta, il passo che attraversa la soglia tra la vita e la morte, un passo meditato e fortemente voluto.
Ma prima di questa soglia c’è stata la vita. C’è stato un amore adolescenziale finito tragicamente, una figlia nata troppo presto, un mestiere molto amato che ha portato Martha in giro per il mondo, lei è stata una corrispondente di guerra. Ed è grazie al suo mestiere che la donna riflette in un passaggio cruciale del film, contestando l’idea della malattia come una battaglia da combattere tra il bene e il male, tra la persona e il cancro, “se vinci sei un eroe e se perdi non hai lottato abbastanza”. Come non darle ragione?
Il film racconta i giorni che precedono la scelta. Accanto a Martha c’è Ingrid, l’amica ritrovata che accetta di accompagnarla in questo percorso di consapevolezza e di dolore, lei glielo chiede semplicemente: “i corrispondenti di guerra si fanno sempre accompagnare da qualcuno, siamo come una grande famiglia”.
Incontriamo Ingrid nella prima scena, fa il firma copie del suo libro nella storica libreria Rizzoli di New York, quella dove quarant’anni fa si incontrarono Meryl Streep e Robert De Niro nel film “Innamorarsi”. Un altro mondo, un’altra New York. È così che Ingrid scopre da un’amica comune che Martha è ricoverata per un cancro alla cervice e che non ha più molto da vivere.
Con quella capacità di raccontare il dolore e la morte che lo rende unico e che abbiamo amato in pellicole come “Tutto su mia madre” e “Parla con lei”, Almodóvar affronta il tema della fine scelta consapevolmente con la cifra che gli appartiene e che ogni spettatore riconosce subito: la leggerezza profonda dei dialoghi che niente concedono al pietismo, la luce vivida e obliqua che ricorda i quadri di Edward Hopper – e proprio un quadro di Hopper, “People in the sun”, sarà uno dei fili conduttori del racconto – i colori squillanti degli arredi e degli abiti, il commento musicale di Alberto Iglesias che collabora con Almodóvar da trent’anni.
Il film rappresenta la quotidianità che precede l’eccezionalità, i gesti banali che diventano straordinari di due donne che si tengono delicatamente per mano fino al momento in cui la porta della stanza verrà chiusa e quell’atto semplice dirà che è finita. Ma in quegli attimi quotidiani ancora pieni di vita ci sarà spazio per i sorrisi, per gli sguardi complici di due amiche, per sgranocchiare una carota, per ascoltare gli uccelli che cantano all’alba la loro sinfonia, per ridere di un uomo amato da entrambe e da entrambe apprezzato come amante.
Il film non si chiude con la morte di Martha. Almodóvar sceglie di raccontare il dolore che arriva dopo, lo scandalo che in Italia conosciamo bene: scegliere di morire con dignità è un reato da noi e lo è anche negli Stati Uniti.
Non dico come si conclude la pellicola, c’è una scelta del regista che potrà apparire spiazzante, ma che personalmente mi è piaciuta moltissimo e con la quale il cerchio si chiude.
Se “La stanza accanto” è un film assolutamente imperdibile, lo si deve non solo al regista che ne firma anche la sceneggiatura (il soggetto sta nel libro di Sigrid Nunez “Attraverso la vita”), ma alla bravura straordinaria delle due protagoniste chiamate da Almodóvar in una prova tanto difficile (ma è ottimo tutto il cast a cominciare da John Turturro).
Julianne Moore, un’attrice che non amo, incarna meravigliosamente la sensibilità materna di Ingrid, e grazie a lei lo spettatore vive le emozioni contraddittorie dell’amica che ha il coraggio di condividere un passaggio tanto drammatico. Quanto a Tilda Swinton, è difficile trovare le parole per spiegare ciò che lo spettatore vedrà: perché l’attrice riesce a incarnare la trasformazione progressiva del corpo, del viso, dello sguardo di chi si avvicina alla fine e quel distaccarsi dal tutto che è la vita ha una densità fisica che si tocca e che commuove, proprio perché non cede neanche per un attimo al voyeurismo del dolore.
Insieme a un quadro di Hopper, c’è un racconto a fare da filo conduttore al film. Anzi, sono le ultime parole del racconto “I morti” che chiude la raccolta di James Joyce “Gente di Dublino”.
“La neve cadeva […] anche là, sul cimitero deserto in cima alla collina […] E l’anima lenta gli svanì nel sonno mentre udiva la neve cadere lieve su tutto l’universo, lieve come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e sui morti.”
La neve rosa che volteggia sulle mille luci di New York, sul bosco che protegge l’ultima casa di Martha, su di noi che la guardiamo finalmente serena, con la bocca dipinta dal rossetto che le illumina il viso, come per una festa.