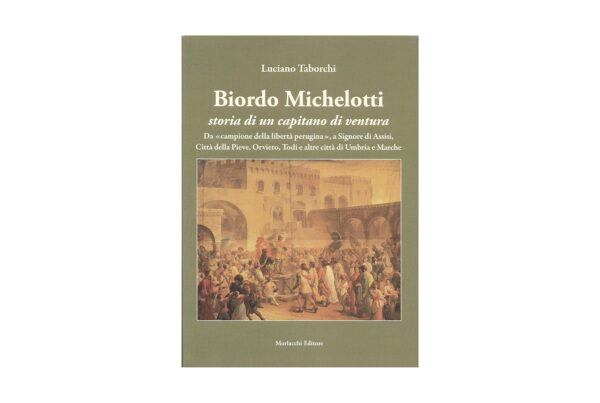di Ida Meneghello
“Noi vogliamo affrontare le sconfinate distese del mare che ci sta davanti, per raggiungere approdi nuovi alla lotta per far avanzare il nostro paese, l’Europa, tutta l’umanità.”
L’uomo che pronuncia queste parole è piccolo di fronte alla folla immensa che le ascolta. La sua fragilità è evidente nella curva delle spalle, nella voce che scandisce senza gridare, nell’accento inconfondibile dell’isola da cui proviene, è sardo come Antonio Gramsci, come Emilio Lussu.
“Berlinguer. La grande ambizione” – il film di Andrea Segre che arriva nelle sale a quarant’anni dalla morte del leader comunista e che ha inaugurato la Festa del cinema di Roma, premiando giustamente il protagonista Elio Germano – è una pellicola in assoluto controtempo rispetto al quotidiano presente della nostra politica, di ciò che è oggi l’Italia.
C’era una volta un popolo che andava compatto a votare per affermare i propri ideali, c’erano in massa i giovani che ci credevano e riempivano le piazze, e c’era un leader che per fare quella politica ha combattuto fino a morirne. Un altro mondo, un’altra vita, la nostra.
Dico subito che il film di Segre non concede nulla all’agiografia e alla santificazione del capo e neppure alla ricerca ossessiva della somiglianza, come fu per Craxi in “Hammamet” di Gianni Amelio. Al contrario rasenta a tratti i toni del documentario, restando nel territorio dell’onesta ricostruzione storica, senza osare quel qualcosa in più che una pellicola può permettersi legittimamente, come se il regista fosse intimidito dal personaggio.
Segre sceglie di raccontare cinque anni cruciali della vicenda politica e umana di Enrico Berlinguer e quindi del nostro paese: dal 1973, quando il segretario del PCI subì un attentato a Sofia ordito dal KGB, al 1978, anno del rapimento e della morte di Aldo Moro. Una stagione in cui coloro che detenevano il potere da sempre, cioè la DC, e coloro che da sempre stavano all’opposizione, cioè il PCI, tentarono di sparigliare le carte, detto in termini scacchistici fecero la mossa del cavallo, cioè spostarsi lateralmente per andare avanti, per superare gli ostacoli che tuttora bloccano la politica italiana nell’eterna e inconcludente contrapposizione del “o con me o contro di me”. Protagonisti di questo tentativo furono Moro e Berlinguer: forte di un’onda micidiale di consensi che oggi ci appare marziana, il segretario del PCI tentò di infrangere i “niet” che erano forti dentro il suo partito e arrivavano fino a Mosca e Moro gli socchiuse la porta del potere, consentendo per la prima volta a un comunista di diventare presidente della Camera. La sua morte segnò la fine di quella grande ambizione, dopo di loro nessuno c’ha più provato perché nessuno ha più creduto possibile il “compromesso storico” tra cattolici e comunisti.
Cinque anni in cui successe di tutto. Il colpo di stato in Cile e la fine della via democratica al socialismo di Allende che ispirava Berlinguer; il referendum sul divorzio; il consenso crescente degli elettori fino al record del 34 per cento alle politiche del 1976; un milione e mezzo di tesserati, i contrasti con Mosca, la strage di piazza della Loggia a Brescia, l’entrata in scena delle Brigate Rosse.
Il regista ha la capacità di innestare nella ripresa cinematografica i filmati dell’epoca fino a renderli indistinguibili grazie alla fotografia che ricalca i toni sbiaditi e la grana delle pellicole di quegli anni. Belle le scene che raccontano il Berlinguer privato, la complicità con la moglie Letizia Laurenti, i giochi al mare con i quattro figli, le fragilità e i dubbi dell’uomo. Certamente il film deve quasi tutto all’interpretazione di Elio Germano e alla sua straordinaria capacità di riprodurre la voce, l’accento e la gestualità inconfondibili di Berlinguer.
Molti spettatori guarderanno questo film come un pezzo di storia che non hanno vissuto. Io l’ho vissuta. Per citare Woody Allen, erano anni pieni di fanciullesco entusiasmo. Mi capitò di intervistare Berlinguer alla Festa nazionale dell’Unità a Bologna nel 1980, c’era appena stata la strage alla stazione. Sembrava impacciato nel suo completo grigio, avvolto nell’ombra protettrice di Tonino Tatò. Lo ricordo sorridente. Nel film beve latte e fuma molto, si intravedono i pacchetti rossi delle Turmac, la scomparsa di queste sigarette fece dire a Carlo Fruttero “nulla ha più senso”.
La sua immagine appare agli antipodi della politica che vediamo oggi, nessuna esibizione, nessuna arroganza, nessuna armocromista, non insultava gli avversari, non rivendicava il possesso della verità. Come diceva Gramsci, aveva una pazienza illimitata ma non passiva, risultato del combinato disposto tra pessimismo della ragione e ottimismo della volontà. Ma neppure corrispondeva al cliché del “compagno”: si lasciò “prendere in collo” da Roberto Benigni, faceva una ginnastica improbabile dove gli capitava, amava andare in barca nel suo mare a cercare quel vento che, nonostante tutto, soffia ancora.
“Spruzza l’acqua alle navi sulla prora
E sussurra canzoni tra le foglie
Bacia i fiori, li bacia e non li coglie”.