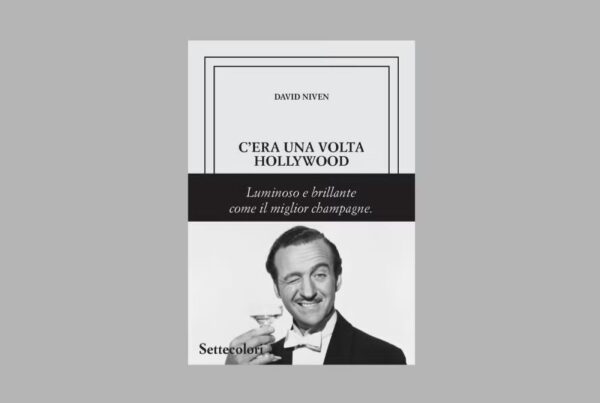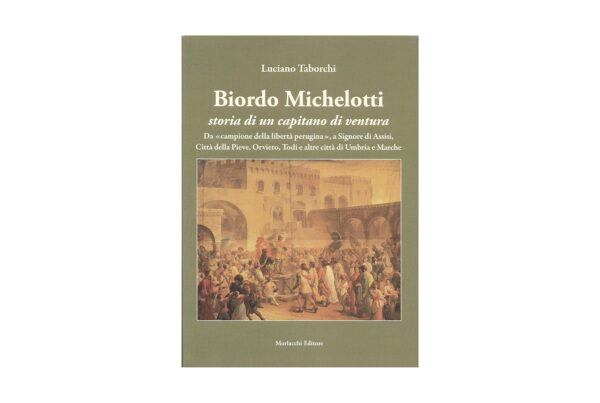In questo secondo articolo sulla crisi del capitalismo democratico Ruggero Ranieri usa come punto di riferimento, i libri di Martin Wolf e di Franco Bernabè. La nuova rubrica di Passaggi si giova anche della collaborazione con la libreria Feltrinelli di Perugia.
di Ruggero Ranieri
Foto ©Gage Skidmore
La malattia del modello di capitalismo democratico, quale lo abbiamo descritto, ha preso un nome e una forma: il populismo. È un processo che è in corso, almeno nelle forme più gravi, da almeno 15/20 anni; investe moltissime nazioni e ultimamente ha determinato le elezioni presidenziali americane, portando all’elezione di un presidente che mostra la volontà non solo di destabilizzare la democrazia americana ma di rovesciare, in qualche modo, l’ordine economico mondiale liberale. Il populismo, nelle sue varie forme e manifestazioni, si manifesta come ostilità verso le élite e rifiuto del pluralismo. Tende a negare la legittimità degli oppositori, dei tribunali indipendenti, della burocrazia imparziale e della stampa libera. I suoi leader si presentano come unici rappresentanti della volontà popolare.
È importante individuare le radici e le origini del populismo e nel farlo mi appoggio sia alle autorevoli analisi di Martin Wolf, sia a quelle di Franco Bernabè, che oltre a essere stato un esponente di punta della nostra classe dirigente economica, interviene spesso, con molta lucidità, sulla storia recente. [Franco Bernabè con Paolo Pagliaro, In trappola. Ascesa e caduta delle democrazie occidentali (e come possiamo evitare la Terza guerra mondiale), Solferino, 2024]
Le origini del populismo sono culturali, sociali e economiche, ma i fattori economici sono nettamente prevalenti e ne spiegano molto bene la tempistica. Vi sono due processi alla sua base: uno di lungo termine e uno più immediato, legato agli effetti devastanti della crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e poi protrattasi in una lunga fase di recessione e stagnazione.
Secondo Wolf molto importanti sono le tendenze di lungo periodo, a partire dagli anni 1980 in poi, contrassegnate, nelle società liberali occidentali, ma non solo, da bassa crescita della produttività e impressionante allargarsi delle diseguaglianze sociali, che le politiche redistributive hanno fatto poco per arginare – e questo vale soprattutto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, ma l’Italia non ha fatto molto meglio. Questi processi sono stati accompagnati da una progressiva deindustrializzazione con l’erodersi della base manifatturiera, dalla precarizzazione del lavoro e da una forbice sempre più larga fra forza lavoro qualificata e lavoratori senza qualifica.
L’attenzione non va posta, secondo Wolf, tanto su politiche economiche errate ma su fattori strutturali. Si è affermato, infatti, progressivamente un capitalismo della rendita, consistente nella finanziarizzazione dell’economia e l’emergenza di colossi bancari globali, che non potevano e non possono fallire, pena il collasso dell’intero sistema e quindi beneficiano di un implicito sostegno pubblico (moral hazard), che infatti non ha mancato di verificarsi nel 2008-2009. Si sono, inoltre, estesi i monopoli e gli oligopoli dando vita a lobby potenti che condizionano la politica e un mondo societario gestito e controllato da grandi manager, che guardano al breve piuttosto che al lungo periodo, speculando piuttosto che investendo. Insomma, un capitalismo “truccato” che ha perso la fiducia dei ceti medi e della maggioranza della popolazione, per ragioni oggettive (mancanza di opportunità economiche e sociali per la bassa crescita dei redditi) e soggettive (un capitalismo “truccato” “rigged”, che non rispetta le regole del gioco). Cosa hanno dovuto pensare milioni di cittadini, consumatori e contribuenti, quando hanno visto che le grandi istituzioni che hanno portato al crollo dell’economia europea e americana sono state generosamente sovvenzionate, mentre i propri redditi, il proprio benessere e le proprie aspettative erano duramente colpiti?
Ci sono stati degli errori specifici che hanno determinato questa situazione? Su questo punto è molto chiara l’analisi di Bernabè. Fu durante la presidenza Clinton che vennero prese le misure più drastiche; la rivoluzione neo-liberale di Reagan e della Thatcher prese definitivamente forma per mano dei suoi supposti avversari. Quali furono queste misure? La liberalizzazione dei mercati finanziari, la deregolamentazione della tecnologia, lo smantellamento delle protezioni sociali, l’ingresso della Cina senza condizioni dell’Organizzazione mondiale del Commercio, la transizione dal socialismo reale nell’Est Europa condotta dalle istituzioni americane e occidentali a colpi brutali di privatizzazioni e liberalizzazioni. Nessuna di queste misure era obbligata. Furono tutte dettate da una hybris ideologica liberista, che assegnava un potere taumaturgico ai mercati, trascurando molti altri fattori, non ultima la lezione della gradualità dell’uscita dalle restrizioni di guerra e dallo statalismo, che aveva accompagnato il capitalismo democratico dopo il 1945.
Negli anni Novanta quando quelle politiche vennero impostante, il clima era di grande ottimismo, la crescita trainata dalla rivoluzione digitale era robusta, si parlava addirittura di fine della storia. Sul piano internazionale prevaleva la visione di esportare la democrazia liberale in un mondo unipolare a immagine e somiglianza degli Stati Uniti, pensando in modo molto superficiale a una espansione ormai inarrestabile del capitalismo democratico, senza averne valutato a pieno né la vera natura, né le immanenti fragilità. Fu la stagione degli Alan Greenspan, dei Robert Rubin, dei Lloyd Bentsen e dei Lawrence Summers.
Gli effetti negativi di tutto ciò non sarebbero tardati. Con le misure di Clinton, per esempio, cadde la separazione fra credito commerciale e attività di investimento finanziario, già un pilastro dell’economia americana dal New Deal in poi e con il Commonwealth Trade Modernization Act si aprì la strada al Risiko dei sub-prime, con il cataclisma conseguente. Ci furono, poi, dei passi indietro di Obama ma molto in ritardo e non decisivi.
Ancora più trasformativa la deregolamentazione della tecnologia: con il Communication D. Act section 230, nessun fornitore utente di un servizio informatico interattivo poteva e può essere considerato l’editore o il promotore delle informazioni fornite da un altro fornitore di contenuti informatici. Massima libertà quindi ai giganti del web, che in quella fase sembravano idealisti portatori di democrazia; oggi appaiono un oligopolio globale, strumento di disinformazione.
Qui si tratta di decidere: furono scelte quasi ineludibili, trainate dallo sviluppo dell’economia e della tecnologia o furono peccati di grave di presunzione intellettuale oltre che di colpevole incapacità analitica? Da un punto di vista di chi crede, come me, alle virtù del capitalismo democratico e alla possibilità di riforme, vale la seconda ipotesi.
Ci furono voci dissenzienti? Poche e inascoltate. In Europa Jacques Delors predicava misure sociali che accompagnassero il mercato e la moneta unica, ma il consenso era virato verso l’esaltazione pura e semplice della competizione e lo smantellamento delle politiche industriali. La sinistra, d’altro canto, trascurava i temi sociali e si concentrava sulla correzione di ingiustizie per motivi di appartenenza razziale ed etnica, identità di genere e preferenze sessuali (diritti di seconda generazione). Lo ha fatto spesso con notevole dogmatismo, alienandosi il consenso di una base tradizionalista, sensibile al populismo.
Le crisi degli ultimi 15 anni sono state un moltiplicatore di queste tendenze, in quanto hanno portato da una parte a salvataggi statali, dall’altra a un impoverimento generale tramite politiche di austerità. L’establishment, a corto di idee e strumenti, si è spesso rifugiato in soluzioni tecnocratiche – l’Italia ne è stata uno dei migliori esempi. Questo ha dato ulteriori munizioni al populismo: il popolo, la nazione, ne sarebbero state esautorate, il voto popolare annullato. Soprattutto le crisi hanno minato la fiducia popolare nelle classi dirigenti e nelle élite e, quindi, soprattutto nelle forze progressiste, di cui le élite venivano ritenute espressione. L’immigrazione crescente è stato un fattore aggravante, spesso una miccia, ma non va vista come la causa del populismo. Ha fornito argomenti a culture conservatrici e identitarie che preesistevano da lungo tempo: un sostrato su cui si è inserita l’ansia delle classi popolari. Quando una maggioranza perde la fiducia nelle classi dirigenti, la può riporre in “chiunque”, lasciando spazio ad avventurieri e demagoghi.
È a questo punto che la destra, dominata da una élite economica, ha avuto via libera per conquistare voti e fare leva su questioni anche razziali per attrarre gli elettori meno istruiti e più poveri. Oggi siamo a questo punto. Leadership populiste elette offrono certezze e autoritarismo, dove sono all’opposizione predicano soluzioni fantasiose ai problemi della società e minano le fondamenta del capitalismo democratico. Le recessione democratica è in atto e le forze populiste hanno il vento in poppa. Si può reagire?