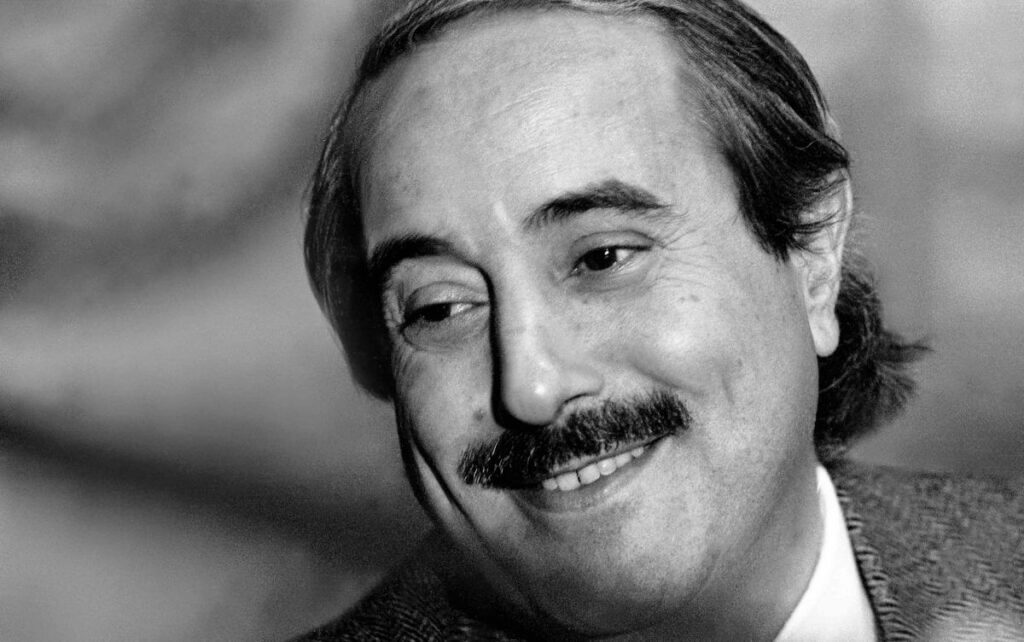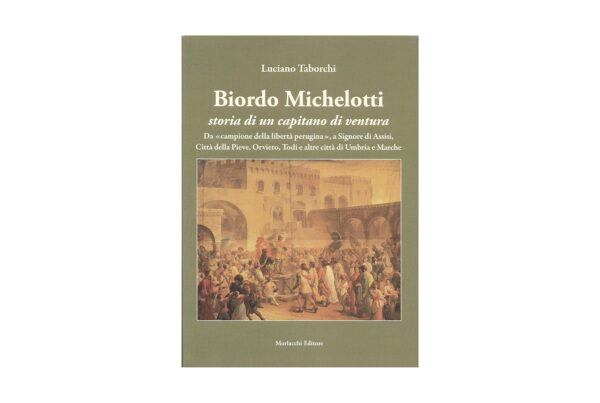di Ida Meneghello
“L’interpretazione dei segni, dei gesti, dei messaggi e dei silenzi costituisce una delle attività principali dell’uomo d’onore. La tendenza dei siciliani alla discrezione, per non dire al mutismo, è proverbiale. Nell’ambito di Cosa Nostra raggiunge il parossismo. […] Su tale principio si basano i rapporti interni alla mafia e i rapporti tra mafia e società civile.”
Giovanni Falcone lo spiegò a Marcelle Padovani nel libro “Cose di Cosa Nostra”, pubblicato sei mesi prima della sua morte. “Iddu”, il film scritto e diretto dai registi siciliani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, presentato a Venezia e in questi giorni nelle sale, film liberamente ispirato alla latitanza di Matteo Messina Denaro, racconta in fondo una storia che riguarda proprio le modalità della comunicazione mafiosa e come esse siano state utilizzate dagli apparati dello Stato per stanare “iddu”, l’ultimo padrino, mettendo in pratica ciò che lo stesso Falcone raccomandava: “magistrati e forze dell’ordine devono adeguarsi”. Ma cosa significhi e quali siano le conseguenze di questo “adeguarsi”, è la domanda che si fa lo spettatore alla fine di una pellicola che merita certamente di essere vista.
La mafia di Messina Denaro non è più quella di Tommaso Buscetta, “Il traditore” raccontato magistralmente da Marco Bellocchio, il pentito che “è stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare con i gesti”, per citare ancora Falcone.
Ciò che resta oggi, e che i due registi rappresentano con efficacia, è un teatro grottesco dove entrano in scena i servizi segreti che pur di catturare il “pupo”, il latitante per antonomasia, ingaggiano un altro “pupo” che ne è il padrino (in paese tutti lo chiamano “il preside”) e che essendo alla bancarotta dopo sei anni nel carcere di Cuneo, accetta di avviare uno scambio epistolare col figlioccio, con l’obiettivo di scoprirne il nascondiglio.
In questa recita i personaggi non hanno niente della nobiltà dei pupi siciliani e neanche della tragicità di Buscetta. In scena arriva “u scarmazzu” cioè il depistaggio dei servizi che, come spiega il colonnello Schiavon alla collega che non ha capito, mira “a mantenere un equilibrio, precario ma vitale. Un giorno, nel maturare delle giuste condizioni, arriverà anche la sua ora”, l’ora di prendere “il pupo”, un soprannome che la dice lunga perché dietro i pupi c’è sempre qualcuno che li manovra.
E con i servizi arriva pure la “camurrìa” dei rompiscatole come Catello Palumbo, il padrino di cresima del boss, meschino tra i meschini, in testa un riporto inguardabile, addosso tute da ginnastica con gli elastici molli, una vita in piccoli appartamenti con brutti tinelli marron.
Quale sia l’atmosfera in cui si dipana questa storia in bilico tra crudeltà, grottesco e ridicolo (in una terra in cui il ridicolo uccide più delle pallottole, come sottolinea Catello), i registi ce lo dicono fin dalla prima scena: la morte del boss Gaetano Messina Denaro, padre di Matteo, non avviene in un palazzo circondato dalla famiglia affranta, ma in un capannone tra le pecore. Accanto al letto del genitore agonizzante c’è solo il figlio più piccolo destinato a prenderne il posto, Matteo, il prescelto perché fin da bambino dimostrò obbedienza cieca, l’unica virtù che Cosa Nostra esige. Un passaggio di testimone sancito dalla consegna del tesoro di famiglia: l’Efebo di Selinunte che la gente chiama, ed è una coincidenza, “u pupu”.
In questa atmosfera crepuscolare da fine dei giochi, nel pulviscolo della luce obliqua dei pomeriggi siciliani, avviene lo scambio epistolare tra padrino e figlioccio, nomi in codice Salustio ed Emanuele, grazie ai celebri “pizzini” ripiegati con cura e magari nascosti sotto le branchie di un pesce.
E se il film vale la visione è innanzitutto merito dei due attori protagonisti di cui è nota la bravura, ma in questa pellicola si mostrano al loro meglio: Elio Germano è Messina Denaro, lo sguardo schermato dai Ray-Ban, il sorriso beffardo, la Beretta nella cintura dei pantaloni, la perfezione della naturalezza; e Toni Servillo incarna Catello Palumbo, finalmente senza ricorrere agli eccessi del mattatore teatrale, patetico e grottesco quanto basta. Intorno a loro un cast eccellente di attori collaudati: Elisabetta Pedrazzi è Elvira, la moglie di Catello, Roberto De Francesco è il Senatore, Barbora Bobulova è Lucia Russo, la vedova-badante del boss, mentre il Colonnello dei servizi Emilio Schiavon è affidato a Fausto Russo Alesi, tra gli interpreti prediletti di Bellocchio. Ciliegina sulla torta: la colonna sonora di Colapesce.
La pellicola gioca su efficaci cambi di ritmo, oscillando dai momenti onirici in cui l’azione procede al rallentatore, quando il boss evoca episodi dell’infanzia e l’assenza lancinante del padre, all’accelerazione incalzante del thriller, in una mescolanza che dimostra la capacità dei registi di non limitarsi a riprodurre la storia cui il film si ispira, ma trovando un punto di vista originale che la trasforma in una chiave di lettura che va oltre il racconto di una latitanza trentennale per molti versi inspiegabile.
I registi hanno spesso evocato nel corso delle interviste le parole di Falcone: “smettiamola di definire mostri i mafiosi, lo sono in termini criminali, ma queste persone ci assomigliano.” Questo è ancora più vero per Messina Denaro, che non era Riina, aveva abitudini borghesi, era un cinefilo e leggeva Baudelaire, Vargas Llosa, Dostoevskij. “Non si tratta di umanizzare, ma di capire”, sottolineano Grassadonia e Piazza. Ciò che fece Falcone con Buscetta. Credo che questo film gli sarebbe piaciuto.