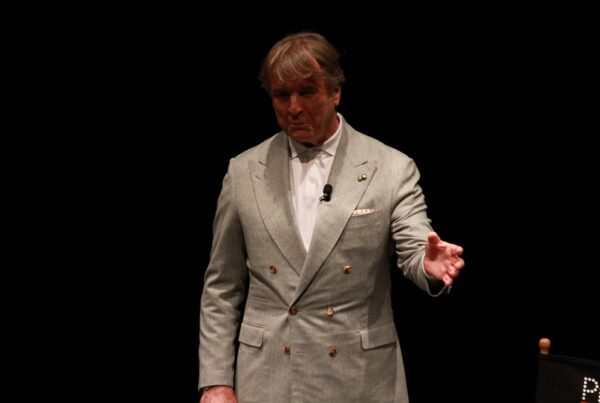di Filippo Tantillo*
All’inizio di aprile è uscito il Piano Strategico Nazionale Aree Interne 2021-2027 (PSNAI). Redatto negli uffici centrali del Ministero per gli Affari europei, il PNNR e le Politiche di Coesione, ha rappresentato la nuova linea di indirizzo dello Stato verso le politiche a favore di migliaia di piccoli comuni italiani, per lo più montani, collinari o rurali.
Da qualche tempo il documento è diventato oggetto di presenti critiche e di discussioni così accese che il Ministero stesso è stato costretto a fare un parziale passo indietro. A scatenare un vero putiferio è stata una frase contenuta a pagina 45 del nuovo PSNAI, dove si legge che alcune di “queste aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento”.
Si tratta di una torsione di 360 gradi rispetto alle scelte che hanno orientato le politiche pubbliche negli ultimi 15 anni: di fatto si rinuncia all’idea di invertire la tendenza allo spopolamento delle aree interne contro il quale si combatte in tutta Europa, e che ha visto l’Italia fare da apripista con politiche innovative e investimenti.
I primi a ribellarsi sono stati i sindaci dei comuni delle aree interne. Hanno seguito a ruota molte regioni.
In alcune di queste, come nelle Marche, il tema è entrato pesantemente in campagna elettorale, in vista delle elezioni regionali che si terranno in autunno. E’ infatti dell’inizio d’agosto la notizia che Il governo ha deciso di allargare la Zona Economica Speciale anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria. È un provvedimento che ha direttamente a che vedere con le aree interne della regione, per le quali la questione politica sembra giocarsi sull’estensione di benefici fiscali per l’insediamento di imprese e soprattutto di nuovi cittadini in queste aree. Va detto che nella regione Marche le aree interne rappresentano, fra le tre aree della vecchia programmazione 2014/2020 (Alto maceratese, Appennino basso pesarese e anconetano, Ascoli Piceno) e le tre nuove della programmazione 2020/2027 (Alto fermano, Potenza Esino Musone, Montefeltro e alta valle del Metauro) il 46% del territorio regionale, e il 35 per cento dei comuni, in pratica l’intera fascia appenninica. Il tasso di spopolamento in questa fascia d’Appennino tra Umbria e Marche, complici gli eventi sismici che lo hanno coinvolto, è uno dei più alti d’Italia.
Come segnala la CGIL Marche, dal 2013 al 2023 le aree interne della regione hanno perso oltre 5.000 attività economiche e più di 600 imprese manifatturiere. I redditi risultano inferiori di quasi 2.000 euro rispetto alle altre zone delle Marche, con una spesa sociale nettamente più bassa (93,7 € pro capite contro 117,3 € degli altri comuni). Anche il numero di studenti è in calo (-2,4%).
Ma in realtà i benefici fiscali, come insegna l’esperienza della Strategia Nazionale per le aree interne, non sono sufficienti a invertire il trend di spopolamento di queste aree. Non a caso il candidato alla presidenza della regione dell’opposizione, Matteo Ricci, insiste sulla necessità di tornare ad investire nel welfare di queste zone, in termini di miglioramento della viabilità, di servizi sanitari diffusi, di scuole attraenti.
Vale la pena ricordare che quelle che vengono definite, a livello nazionale, “Aree Interne” rappresentano circa la metà dei comuni italiani e quasi il 60% del territorio nazionale, nelle quali risiede oltre il 22% della popolazione, più di 13 milioni di persone. Fragili ma tutt’altro che povere, queste aree contengono una parte rilevante di quel patrimonio culturale e ambientale, oltre alle energie che permettono ad un paese piccolo come il nostro di giocare un ruolo importante sul mercato globale nei settori dell’artigianato industriale specializzato e in quello agricolo, attraverso la grande varietà di prodotti che derivano da una agricoltura estremamente diversificata.
In pratica, i territori che compongono questo pezzo di Paese sono diventati luoghi strategici per il futuro della nostra economia. Tuttavia le carenze dei servizi e delle infrastrutture rendono ad oggi la vita in questi luoghi molto dura. Per questo, nel 2012, su impulso dell’allora Ministro Fabrizio Barca, è stata lanciata una politica per contrastarne il declino demografico puntando su investimenti per ripensare i servizi sanitari, scolastici e di trasporto disegnati intorno alle persone. Ma è evidente che quello che è stato fatto finora ancora non basta.
Anche la regione Umbria, per voce di Simona Meloni, assessora al PNRR, alle politiche agricole e agroalimentari, alla montagna e alle aree interne, ai parchi e ai laghi, al turismo e allo sport, sta provando ad andare oltre quello fatto fin’ora, e ha contestato il Piano strategico che condannerebbe all’abbandono parte dei comuni appartenenti alle aree interne regionali, per lo più concentrati nell’area della Valnerina, e annunciato un progetto, già varato dalla giunta regionale, che si chiama ‘Valnerina Accogliente’, un pacchetto di interventi che va nella direzione opposta rispetto a quella prevista nel Piano strategico nazionale, e che mette a disposizione del territorio risorse per oltre 9,2 milioni di euro, destinate a rafforzare mobilità, cultura, promozione, occupazione, servizi alla persona e infrastrutture educative.
Bisogna tenere in considerazione che i comuni umbri appartenenti alle 5 aree interne regionali sono 59, pari a ben il 64% dei 92 comuni umbri. La popolazione totale interessata dalla Strategia delle Aree interne è pari al 26% della popolazione totale regionale, all’incirca 226 mila abitanti. Le cinque aree interne regionali hanno prodotto (3 nella prima fase, Valnerina, Sudovest orvietano e Nord est Umbria) o stanno producendo (le due nuove della programmazione 2020/2027, Unione dei comuni del Trasimeno e Media Valle del Tevere) delle “strategie d’area” partecipate per l’individuazione degli interventi, tanto sul miglioramento dei servizi che sulle misure per favorire lo sviluppo . Le strategie territoriali di sviluppo di questa nuova fase verranno finanziate per 40,23 milioni di euro da fondi di coesione (cioè fondi europei programmati dalle regioni) – nonché da fondi provenienti dalla Legge di stabilità nazionale, per un importo pari a 8 mln di euro.
L’idea di fondo che muove queste strategie è molto lontana dal cosiddetto “assistenzialismo”, quelle politiche “compensative” di mancati investimenti strutturali che sono all’origine della decadenza e marginalizzazione di queste aree, ma punta alla promozione di una vera e concreta rigenerazione economica, una valorizzazione del capitale umano e culturale, una implementazione dei servizi di welfare (istruzione, sanità e sociale) che abilitino il diritto di cittadinanza. La centralità della “partecipazione” che la SNAI affida alla costruzione delle strategie territoriali nasce da una presa d’atto da parte delle istituzioni che non esiste una risposta univoca ai bisogni locali ma che sia necessario ‘leggere’ e ‘ascoltare’ attentamente i territori e lavorare per costruire azioni integrate e coordinate. Il destino dei nostri comuni più piccoli ma anche delle nostre città medie, dice l’assessora, non è segnato.
*Filippo Tantillo è ricercatore, esperto di politiche del lavoro e dello sviluppo, lavora da più di 20 anni con Istituti di ricerca e università italiane ed europee alla messa a punto di nuovi strumenti di ascolto del territorio e dei fenomeni sociali. È stato coordinatore scientifico del Comitato Nazionale per le Aree Interne, per conto del ministero della Coesione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ autore del saggio “L’Italia vuota” (Laterza)