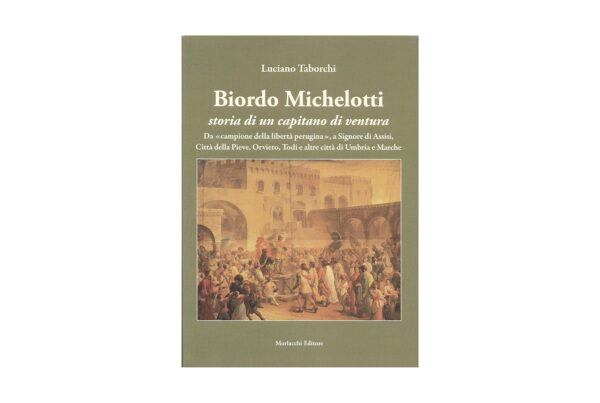di Ida Meneghello
Lo scrivo subito: non appartengo al popolo che considera Bob Dylan il più grande cantautore di tutti i tempi (anche se è l’unico ad avere vinto un Nobel). Nessuno è perfetto, direbbe Billy Wilder.
Ma credo che non essere dilaniata da Dylan sia un vantaggio, perché non solo mi evita di schierarmi a priori pro o contro il film di James Mangold “A complete unknown”, ma mi ha permesso di guardarlo senza aspettative (anche se si è aggiudicato 8 nomination agli Oscar).
Secondo vantaggio: posso evitare di fare confronti con i due capolavori preesistenti, cioè il documentario “No direction home” di Martin Scorsese e soprattutto l’eccentrico “I’m not there” di Todd Haynes, dove Dylan era interpretato da sei attori diversi tra i quali spiccava Cate Blanchett.
Dopo questa premessa, com’è il nuovo biopic che racconta Dylan negli anni dell’esordio, dal 1961 al 1965, quando arrivò a New York per conoscere Woody Guthrie che era il suo mito e nell’ospedale dove lui era ricoverato incrociò Pete Seeger e da lì tutto ebbe inizio? Anche questo lo scrivo subito: “A complete unknown” è un film bellissimo. Ecco le ragioni per le quali merita di essere visto.
La prima e più ovvia ragione è l’interpretazione straordinaria di Timothée Chalamet. Essendo una pellicola che ancora una volta porta sul grande schermo l’idolo di milioni di devoti, la sua performance è il primo fattore che condiziona il giudizio sul film. Chalamet dal 2017, cioè da “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, è una star assoluta e a neanche trent’anni incarna l’idea stessa della giovinezza. Con tale carisma entra nella parte anima e corpo, di più, fa ciò che nessun attore per quanto dotato aveva osato prima di lui: suona (chitarra, armonica, piano, proprio come Dylan) e canta in presa diretta, altro che i playback di Angelina Jolie in “Maria”!
Chalamet vince una scommessa spericolata: ha lo stesso timbro, la stessa voce un po’ nasale e quella pronuncia strascicata che si mastica le parole e allunga le vocali appoggiandole sulle note. Prende la chitarra e infila accordi e arpeggi come fosse un professionista. E poi i gesti, gli sguardi, la mimica facciale, le sigarette accese una dopo l’altra e quella camminata ciondolante che abbiamo guardato mille volte nei video e nelle cover dei suoi album. Insomma è irresistibile.
La seconda ragione sta nella capacità del regista di ricreare l’atmosfera dei mitici Sixties americani: lo spettatore si siede tra il pubblico dei club del Greenwich Village, entra nelle sale di registrazione e applaude tra la folla del Newport folk festival dove Dylan esordì nel 1963 diventando subito un fenomeno di massa. La sceneggiatura si basa sul libro “Dylan Goes Electric!”di Elijah Wald ed è stata accuratamente vagliata e approvata dallo stesso artista.
La terza ragione è il cast. Accanto a Chalamet-Dylan compaiono i protagonisti di una stagione irripetibile: Joan Baez, Pete Seeger, Johnny Cash, Woody Guthrie. E tutti sono restituiti alla nostra memoria con tenerezza complice, a cominciare dall’ottimo Edward Norton che interpreta Seeger.
La quarta e non ultima ragione è ciò che il film ci racconta del personaggio fin dal titolo: un artista destinato a restare un unicum in fondo incomprensibile.
“A complete unknown” ci mostra un ragazzo di vent’anni un po’ timido e un po’ sfacciato, che scrive testi come un poeta e inventa ritornelli che si incastrano subito con le parole e diventano canzoni che saranno cantate da milioni di persone. Il ragazzo capisce presto che gli altri lo vogliono possedere, gli vogliono far fare ciò che loro decidono, gli chiedono da dove vengono quelle canzoni perché loro non sono capaci di farle, quel ragazzo è un marziano che vuole fare solamente la sua musica e se decide di farla amplificata con una chitarra elettrica rinunciando alla classica sei corde, se decide di “tradire” il pubblico che lo idolatra, bisogna lasciarlo fare, perché lui sa che i tempi stanno cambiando.
“A complete unknown” è un film pieno di scene emozionanti e coinvolgenti: preparatevi a condividere il brivido che fa balzare in piedi la folla del Newport folk festival per cantare con lui “The times they are a-changin’”.
Queste stesse parole furono scelte parecchi anni dopo dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco per intitolare la sua Lectio nell’aula magna dell’università di Bologna: Visco rifletteva su un mondo lontano anni luce dall’America folk degli anni Sessanta, eppure le parole di quella canzone lo descrivevano ancora perfettamente.
Forse Dylan è davvero il più grande cantautore di tutti i tempi.