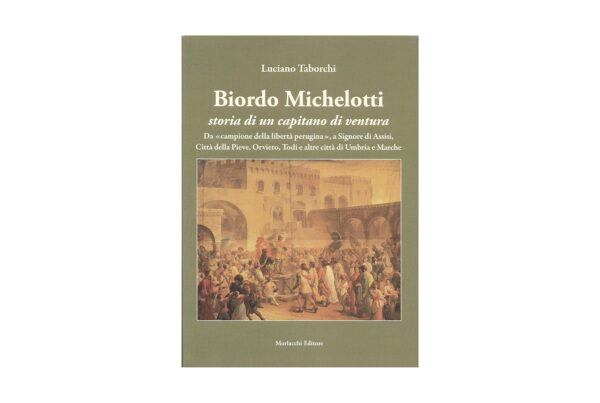di Pier Mario Fasanotti
Altrove. La perdita di una persona cara genera il lutto, che è un’esperienza traumatica. Spesso la malattia o la morte eliminano ciò che dà senso alla nostra vita. Si sprofonda nel dolore oppure nella nostalgia. In ogni caso il senso del futuro impallidisce, o addirittura scompare. Nel suo più recente saggio, Massimo Recalcati, uno dei nostri massimi filosofi (è anche psicoterapeuta), si mette alla ricerca di qualcosa che non sia una resa totale. Lo fa con La luce delle stelle morte (sottotitolo: Saggio sul lutto e nostalgia, Feltrinelli, 133 pagine, 16 euro). Prendiamo in considerazione la perdita che, scrive l’autore, «si ripete più volte nella nostra esistenza perché la vita non può che scorrere attraverso i suoi innumerevoli morti; non solo quelli che sono effettivamente defunti, ma tutte le morti – tutte le perdite – che abbiamo simbolicamente vissuto».
L’avverbio «simbolicamente» estende a non finire il vuoto che avvertiamo dentro di noi. Quanto alla nostalgia, ne esistono diverse forme. Se il lutto può diventare cronico (di qui la malinconia), è anche in grado di essere negato (di qui la mania). Il punto in comune tra nostalgia e lutto si ha quando «il carattere irreversibile della perdita si associa alla necessità di recuperare quello che abbiamo perduto… tuttavia nessuno può ritornare dalla morte, così come nessuno può ritornare al tempo mitico dove la nostalgia vorrebbe portarci», per esempio alla giovinezza, alle amicizie, agli affetti, alle occasioni di lavoro, ai progetti. Recalcati avverte che la nostalgia ha due diversi volti: «il primo è quello del rimpianto, il secondo è quello della gratitudine», nel senso che molte cose rimangono dentro di noi e attorno a noi. E allora diventa «una potente risorsa psichica di rinnovamento della vita». L’analisi compiuta da questo saggio – proposto con un linguaggio mai oscuro – è lucida, a volte spietata, capace di infilarsi nelle pieghe di sentimenti e sensazioni che a volte paiono suggerirci.
Ironia. Il popolo che è per eccellenza il più auto-ironico è quello ebraico. Si tratta di una comicità spesso irriverente nei confronti di Dio, che parte storicamente dalla necessità di proteggersi in
www.passaggimagazine.it
situazioni estreme o comunque in mezzo ad accuse, pregiudizi e sarcasmo. Un’ottima disamina di questo argomento la compie Luca De Angelis in L’uomo pesa, Dio ride (Marietti 1820 editore, 277 pagine, 17 euro). L’autore spiega che spesso è l’angoscia ad accendere il meccanismo del riso. Qualche esempio. Proverbio ebraico: «Se Dio vivesse sulla terra, tutti vorrebbero rompere i vetri delle sue finestre»; «Dio ha riso e ha detto “I miei figli mi hanno vinto”», si legge nel Talmud; il regista (ebreo) Woody Allen fece dire a un suo personaggio: «Ma se Dio esiste, spero che abbia una buona scusa». In questo saggio si cita sovente il romanziere Romain Gary, nel cui capolavoro, L’angoscia del re Salomone, si ritrova il senso e l’anima dell’umorismo ebraico. Altri letterati se la prendono con la «la latitanza» del Creatore, soprattutto tra il 1939 e il 1945, anni in cui i nazisti fabbricarono la più odiosa e innominabile macchina di sterminio, la Shoa. Ci sono domande che fanno male anche dietro ai baffi di un uomo che ride: «…Dio è un lavativo, del tutto disinteressato alle sofferenze dell’umanità… uno che sta nel suo cantuccio, come uno scarafaggio sotto il sole…». Si legge nel romanzo L’uomo di Kiev, di Malamud, la spiegazione irriverente: «Dio è con noi finché i cosacchi non arrivano, al galoppo. Allora è da qualche altra parte. È al cesso. Ecco dove è». Un altro scrittore, Béla Zsolt, si chiedeva se Dio poteva essere impotente in certi periodi della Storia. Ma, aggiungeva, «dal momento che con l’Altissimo ci si litiga – non si pretende nulla da qualcuno che non può fare niente – forse è semplicemente ottuso… o forse è impotente, non è capace di escogitare scuse o accampare difese… è forse questa la ragione della terribile pausa…».