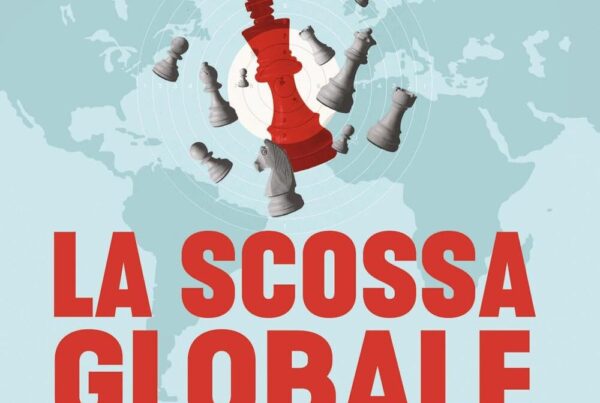di Ida Meneghello
Venezia 1980, prima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale diretta da Paolo Portoghesi. Il pubblico affolla il padiglione dedicato all’architetto ebreo ungherese László Tóth e intitolato “L’impronta del passato”. L’architetto è in carrozzina, appare assente e molto più vecchio dei suoi 69 anni. La nipote Zsòfia prende il microfono e in poche frasi riassume la sua vita, il destino drammatico che ha condiviso con la generazione degli europei schiacciati tra la Grande Guerra e la Germania di Hitler, un passato che ha lasciato impronte profonde nella sua visione dello spazio. “Non importa cosa cerchino di vendervi gli altri, è la destinazione che conta, non il viaggio“, sono le sue parole conclusive.
Inizio dalla fine per raccontare “The brutalist”, scritto, diretto e co-prodotto dal regista statunitense Brady Corbet, perché la chiave del film secondo me sta nell’epilogo, in quella scena alla Biennale di Venezia in cui tutto appare vero (tanto che ti chiedi chi è l’architetto László Tóth e perché non ne sai niente) e invece è pura invenzione. Ma non è fiction la storia potente del personaggio che sopravvive all’Olocausto, attraversa l’Europa e l’Atlantico e si è già meritata 10 nomination agli Oscar, dopo aver conquistato tre Golden Globe e il Leone d’argento per la migliore regia. Secondo molti la storia dell’architetto Tóth avrebbe meritato il Leone d’oro.
Non sapevo niente del “brutalismo”, la corrente di architettura e design nata negli anni 50 in Gran Bretagna e di cui l’esempio italiano più significativo è la Torre Velasca a Milano. Ho scoperto che deve il suo nome all’uso del cemento a vista (in francese béton brut), materiale grezzo che invece di restare nascosto nella struttura viene esaltato dal progetto. “Il brutalismo è qualcosa che le persone non comprendono e quindi vogliono abbattere” ha spiegato il regista. Insomma è una metafora del diverso da noi, ciò di cui diffidiamo e che vorremmo eliminare.
Cosa racconta la storia scritta dal regista americano insieme alla compagna Mona Fastvold? Il protagonista è un architetto ebreo scampato al campo di sterminio di Buchenwald. È alto, magrissimo, ha il naso rotto che gli procura un dolore lancinante, lo sopporta solo grazie all’eroina. Cresciuto col Bauhaus di Walter Gropius, Tóth sbarca a New York nel 1947 e raggiunge il cugino Attila che nel frattempo ha aperto un negozio e un laboratorio di mobili a Philadelphia. L’uomo è solo, la moglie e la nipote sono rimaste bloccate alla frontiera austriaca. Per lui inizia la strada tutta in salita dell’integrazione, parla l’inglese “come un lustrascarpe”, si adatta a fare qualsiasi mestiere, dorme fra i senzatetto con gli incubi angoscianti dell’ebreo sempre in fuga. Ma un giorno il ricco costruttore Harrison Lee Van Buren scopre la sua genialità e la storia da cui proviene, ne è affascinato e gli commissiona, vincendo i pregiudizi della sua comunità wasp, il progetto di una struttura imponente intitolata alla madre: sale conferenze, biblioteca e una cappella per pregare.
Un prologo, due capitoli (“L’enigma dell’arrivo” e “Il nocciolo della bellezza”) e l’epilogo alla Biennale di Venezia.
“The brutalist” è un film che ha una potenza visionaria, epica. Soprattutto nel primo capitolo che racconta lo spaesamento di un sopravvissuto all’Olocausto nell’America del dopoguerra dove tutto sembra possibile, ma dove Tóth resta, nonostante il suo genio, uno straniero, per di più ebreo. Il suo orgoglio ferito gli fa dire “non permetterò alla mia gente di vedermi come un mendicante: mai”. È un orgoglio che il potere di Van Buren, cioè della società che non accetta quel corpo estraneo, vorrà piegare, umiliare in tutti i modi.
E allora capisci che è Tóth stesso il cemento brutale, lui è più forte delle violenze e delle umiliazioni che subisce, più forte dei pregiudizi che lo condannano alla solitudine, più forte delle droghe che lo irretiscono, più forte del “qui non ci vogliono!” urlato dalla moglie per riportarlo alla realtà che lui non vuole vedere. Perché László Tóth vive solo nei suoi sogni, negli spazi che progetta e che gli altri non vedono, nelle altezze smisurate delle sue architetture che puntano verso la luce del cielo. Il campo di Buchenwald gli è rimasto dentro e per uscirne deve ricostruirlo nei suoi progetti: perciò le stanze anguste come celle ma con le altezze vertiginose che indicano la via di fuga, la libertà.
“Perché l’architettura?” gli chiede Van Buren prima di commissionargli il progetto che cambierà la vita di entrambi. “Lei conosce un modo migliore di descrivere un cubo se non farlo?” risponde l’architetto.
La potenza della materia e della mente che la plasma sono il vero soggetto del film. E materico è il film stesso, 87mila metri di girato in pellicola 35 mm formato VistaVision, erano sessant’anni che un film americano non veniva fatto così. Corbet l’ha deciso perché è la tecnica con cui si giravano i film negli anni in cui è ambientata la storia. Rinunciando alla perfezione del digitale tornano i chiaroscuri pastosi della pellicola, talvolta persino sfuocati (o forse sono i proiezionisti che hanno perso la mano).
Solo una battuta sul cast. Un film così potente esigeva un protagonista altrettanto potente. Adrien Brody col suo enorme naso rotto occupa la scena dalla prima all’ultima inquadratura, fragile, rassegnato, disperato, orgoglioso, rabbioso, indomabile. Accanto a lui sono perfetti Felicity Jones nella parte della moglie e Guy Pearce che incarna il personaggio contraddittorio del miliardario mecenate e sopraffattore.
Fare un film di 215 minuti che non ammazza lo spettatore è un miracolo che riesce a pochissimi. “The brutalist” è una storia indimenticabile perché ci ricorda che un pezzetto di quel cemento brutale e resistente a tutto è forse dentro ciascuno di noi.