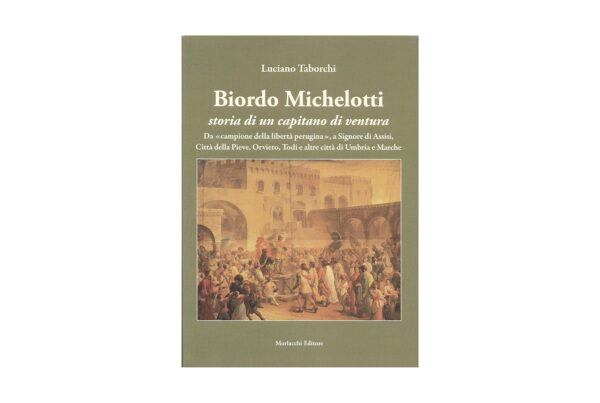di Ida Meneghello
Forse siamo ancora in tempo per salvare il mondo. Ma servono due cose: un patto tra le generazioni e tanto coraggio.
È questo, ma non solo questo, il messaggio contenuto nel nuovo film del regista, sceneggiatore, produttore e direttore della fotografia statunitense Paul Thomas Anderson “Una battaglia dopo l’altra”. Film che ancora una volta spiazza lo spettatore proponendogli un argomento che niente ha a che vedere con le sue pellicole precedenti, si pensi a “Il petroliere”, “The Master”, “Il filo nascosto” o “Licorice Pizza”. Ogni film di Anderson è una storia a sé – bene ha fatto la Cineteca di Bologna a dedicargli in settembre una retrospettiva integrale – e nasce da una lunga riflessione, alla faccia della bulimia produttiva che pare assillare molti registi contemporanei: tra un film e l’altro di Anderson passano tre, quattro anni.
Che cosa racconta “Una battaglia dopo l’altra”? Ispirato lontanamente al romanzo “Vineland” di Thomas Pynchon, il film mette in scena la vita movimentata dalle burrascose battaglie per i diritti civili di Bob Ferguson, attivista e rivoluzionario interpretato dall’ottimo Leonardo DiCaprio totalmente nella parte.
La storia inizia negli anni 90 al confine tra Stati Uniti e Messico, al tempo della costruzione del muro destinato a bloccare gli immigrati clandestini. Ferguson fa parte del gruppo rivoluzionario French 75 e con la compagna afroamericana Perfidia Beverly Hills (la travolgente modella e coreografa Teyana Taylor) si esibisce in performance pirotecniche per portare in salvo le famiglie dei migranti messicani sbeffeggiando i militari Usa. A braccarli senza tregua è il colonnello Steven J. Lockjaw, personaggio perfido e lubrico interpretato da un magistrale Sean Penn.
Fin dalle prime scene lo spettatore riconosce le situazioni grottesche e i dialoghi surreali che molto evocano il cinema di Quentin Tarantino: perché se è vero che gli scambi verbali sono infarciti di “fuck” e “pussy”, lo sono altrettanto di riflessioni paradossali su come va il mondo e sul senso della vita.
Il punto di svolta della storia avviene con la nascita della figlia di Bob e Perfidia, Wilma, che coincide con l’uscita di scena della madre, arrestata e forse uccisa dal colonnello o forse no. Il padre si mette in salvo con la bambina in una sperduta contrada e tutto sembra volgere alla normalità, dimenticando le battaglie della giovinezza rivoluzionaria.
Ovviamente non è così. Perché riprendendo la storia sedici anni dopo, cambia il perno della narrazione che si trasforma nella vicenda di due padri che si contendono una figlia, ed è un paradosso che punta dritto al cuore dell’America com’è oggi: perché è il colonnello suprematista a sospettare di essere (orrore!) il genitore della ragazza nata da un’unione interrazziale.
Non dico altro dei numerosi colpi di scena che Anderson è capace di inventare per mantenere alto il ritmo del racconto e quindi l’attenzione dello spettatore, che non guarderà l’orologio nonostante i 162 minuti della pellicola. Sottolineo che il film vira abilmente dai toni fantastici iniziali al versante grottesco della realtà che conosciamo bene – c’è in controluce tutta l’America MAGA e trumpiana con le sue fobie omofobe e suprematiste – utilizzando con sapienza i registri dell’ironia e del divertimento per raccontare un mondo drammatico. E molto merito di questa riuscita va, oltre che al regista-sceneggiatore, alla bravura di tutto il cast: accanto a DiCaprio e Penn c’è Benicio del Toro nella parte dello strafatto maestro di karate Sensei Sergio St. Carlos.
È alla fine che arriva la risposta salvifica: tra Bob e Wilma avviene il passaggio di testimone che forse offrirà un futuro alle nuove generazioni. Una speranza che riempie il cuore anche dello spettatore e lo convince di aver visto finalmente un grande e imperdibile film.