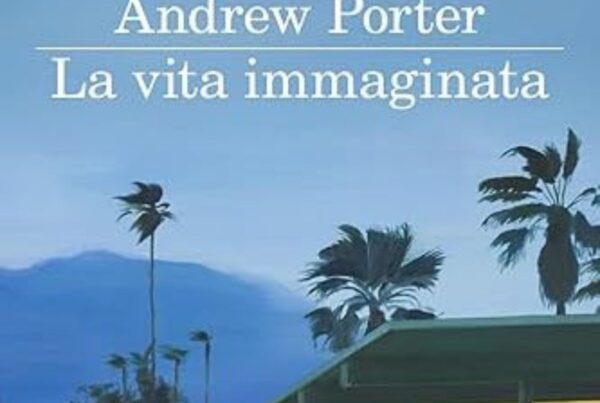L’Umbria dagli anni Sessanta ha programmato il proprio futuro. E oggi? Nessuno propone un progetto per il governo del territorio. Con questo articolo Passaggi apre un dibattito.
di Walter Ceccarini*
Ho letto con grande interesse il saggio che apre il quaderno di Passaggi Magazine sulle infrastrutture e i trasporti di Fabio Ciuffini. Come al solito un’acuta e convincente analisi sulla situazione della regione accompagnata da concrete e moderne proposte sul futuro in materia di mobilità, trasporti e infrastrutture nel nostro territorio.
Nella presentazione dello stesso quaderno Giampiero Rasimelli invitava, di fronte a “scelte storiche” da compiere nei prossimi mesi, ad un confronto approfondito e ad una partecipazione larga e profonda nella società regionale”.
Provo a dare un contributo, con grande modestia, semplicità e senza alcuna presunzione. Per iniziare voglio subito condividere i dubbi e gli interrogativi (forse troppi e troppo grandi e generici) che, durante la lettura del quaderno di Passaggi Magazine, mi hanno costantemente accompagnato, cercando di non allontanarmi dalle forti ragioni che ci dovrebbero spingere a ripensare politiche strutturali di “governo del territorio” anche attingendo ad alcune esperienze del passato che forse possono essere di aiuto.
Avendo presente che “nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare”, il più sostanzioso tra gli interrogativi, almeno per me, è il seguente: si possono fare “scelte storiche”, prendere decisioni importanti senza che, non pretendo in un materiale organico e condiviso, ma almeno nel dibattito pubblico in modo organizzato, nelle principali sedi politiche e istituzionali a partire dalla Regione, ci sia un confronto su una visione forte del futuro dell’Umbria? In quale documento attuale si può ritrovare uno sforzo di analisi della situazione economica e sociale tale da definire un’idea generale del futuro della nostra Regione e del suo territorio (tipo: l’Umbria, cuore verde d’Italia, prima Regione decarbonizzata d’Europa. E’ troppo?) nel contesto nazionale e non solo? Un’idea capace di guidare le nostre decisioni e le nostre azioni, soprattutto se si affrontano temi come la mobilità, le infrastrutture e i trasporti. Da quanto tempo non c’è un confronto su un elaborato che parli di governo del territorio, di riqualificazione delle città, di consumo del suolo, della indispensabile transizione energetica? (A tal proposito, che fine ha fatto il più volte annunciato Piano Paesaggistico?). Insomma, come saranno le nostre città e l’Umbria, mettiamoci una data, nel 2050? Con quali politiche e quali obiettivi pensiamo di affrontare le grandi e inedite sfide del mutamento climatico, del cambiamento energetico, della transizione digitale, dell’inverno demografico, dei nuovi modi di produrre e di vivere?
Penso sia ridicolo e preoccupante riparlare (e in che modo!) di riequilibrio delle due Provincie e non avere nessun confronto su questi temi.
Molto recentemente, nel periodo del COVID e subito dopo, c’è stato un moltiplicarsi di riflessioni e dichiarazioni del tipo: niente sarà più come prima! Poi, per la verità, a distanza di alcuni anni, non solo non ci sono i segni di questo cambiamento (malgrado i tanto decantati soldi del PNRR) ma rischiano di non esserci neanche i presupposti per un dibattito all’altezza delle sfide che tutti definiamo epocali.
E’ possibile che nel valutare questo vuoto incida la mia personale, ormai datata, esperienza e forse pesi anche l’affiorare di una certa ingiustificata e inutile nostalgia. Ma recentemente mi è ricapitata per le mani una copia de “L’Umbria in Parlamento”, la raccolta degli atti parlamentari del 1960 e del 1966 sulla crisi della nostra Regione che Claudio Carnieri, allora Presidente dell’AUR, ha voluto pubblicare con caparbia intelligenza.
Non possiamo pretendere, per molti motivi, una dimensione e una qualità del dibattito paragonabile a quel periodo. Tanto meno possiamo illuderci che si possa arrivare, visti gli attuali rapporti tra le forze politiche, a siglare un Ordine del Giorno come quello approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati nel febbraio del 1960, a conclusione del primo dibattito sulla situazione economica dell’Umbria.
Ma nel merito, e soprattutto da quel clima politico e sociale e in quel metodo possiamo trovare indicazioni attualissime. Ci sono infatti “persistenze” di analisi e di proposta con le quali (proprio facendo riferimento al territorio e alle sue infrastrutture) dobbiamo continuare a fare i conti. Non si tratta solo di prendere atto che oggi come allora siamo ad un tornante della vicenda economica e sociale dell’Umbria. Oggi come allora sono aperte tre crisi fondamentali: economica, demografica e addirittura di identità della nostra Regione. Insomma, come prima ho cercato di dire, abbiamo di fronte una grande “questione sulla prospettiva” che riguarda il territorio e le nostre città da affrontare in una dimensione nazionale ed europea. Una questione che riguarda la collocazione dell’Umbria nelle gerarchie e dinamiche italiane e richiama il tema infrastrutturale come grande problema di “connettività”.
Ecco che torna il problema del “governo del territorio” anche per affrontare le problematiche legate alla transizione energetica (e a tutta l’economia che si può generare intorno alle rinnovabili e all’idrogeno), al cambiamento climatico, alla riqualificazione/rigenerazione delle nostre città e del territorio regionale.
Soprattutto in questo senso penso ci sia di nuovo bisogno di lavorare ad un documento che fissi linee, obiettivi, valori e impegni. Un elaborato che, affrontando strategie per il governo del territorio, faccia riferimento alla sostenibilità ambientale, alla coesione e giustizia sociale, alla competitività e alla capacità di attrazione della nostra regione. Un nuovo Piano Urbanistico territoriale, un nuovo Disegno strategico, l’annunciato Piano Paesaggistico? L’Umbria ha una particolare e specifica conformazione territoriale, una peculiare distribuzione della popolazione e delle attività economiche. Una dimensione policentrica (termine che ha caratterizzato a lungo il dibattito nel passato) che ha pesato sulle scelte urbanistiche e infrastrutturali nei decenni passati.
Se la memoria non mi tradisce, la cadenza è più che decennale per i documenti di riferimento istituzionale sul governo del territorio. Il Primo PUT è del 1983 (policentrismo, città regione), il secondo Piano Urbanistico Territoriale risale al 2000 (Umbria sostenibile cuore verde dell’Italia), Il Disegno Strategico territoriale è del 2008 (Umbria territorio snodo e laboratorio di sostenibilità). Infine, era stato fatto un eccellente lavoro di preparazione (tra cui un interessantissimo convegno –settembre 2015- dei geografi italiani, insieme all’Università di Perugia, l’Università per stranieri e la Regione, che ha portato alla pubblicazione degli atti sulla rivista Geotema: L’Umbria tra marginalità e centralità che doveva portare alla discussione e all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (l’Umbria dei Paesaggi) di cui però si è persa traccia.
Banalmente, penso che sarebbe utile darci di nuovo un obiettivo importante e scegliere il metodo di un largo e qualificato confronto, come auspicato da Rasimelli.
L’obiettivo potrebbe essere quello del Piano Paesaggistico regionale (o un altro documento sul governo del territorio) abbandonando ogni preconcetto, ogni approccio ideologico sui temi della difesa e valorizzazione del paesaggio stesso e del territorio. E soprattutto abbandonando vecchie, parziali e frammentate idee sull’Umbria e dell’Umbria. Facendo della Regione, di tutta l’Umbria, la risorsa fondamentale per dare impulso ad una nuova fase di sviluppo (sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale) e ad una migliore qualità della vita, rispondendo così ad una crisi che ha cambiato nel profondo la struttura del modello legato al secolo precedente. Altro che Bandecchi e il riequilibrio delle Province!!!
Il sociologo Aldo Bonomi, che ha scritto insieme allo storico dell’architettura Roberto Masiero, ormai dieci anni fa, un interessantissimo e, per la nostra riflessione, pertinente libro dal titolo: “Dalla smart city alla smart land”, ripropone l’interrogativo: “il territorio prima lo si abita e poi lo si pensa, o prima lo si pensa e poi lo si abita”. Ovviamente scegliendo la seconda opzione.
“Quella della smart land appare quindi come una promettente prospettiva intorno alla quale sperimentare forme di modernizzazione e civilizzazione delle piattaforme produttive. In questo senso smart land è un ambito territoriale nel quale sperimentare politiche diffuse e condivise, orientate ad aumentare la competitività e attrattività del territorio con un’attenzione specifica alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla fruibilità dell’ambiente (naturale, storico-architettonico, urbano e diffuso) e alla qualità del paesaggio e della vita dei cittadini.”
Per quanto riguarda il metodo guarderei all’esperienza che in Veneto ha portato, su iniziativa di tutte le organizzazioni economiche e sindacali, di tutti gli ordini dei professionisti e di tutte le sigle ambientaliste, a sottoscrivere il “Patto per un programma regionale di strategie politiche di rigenerazione urbana sostenibile. Obiettivi e valori per le città venete del futuro”.
“Non ci sono alternative al futuro, ma il futuro è pieno di alternative. A noi, scegliere e costruire la più desiderabile”. Questo era lo slogan di “Toscana 2050”.
*