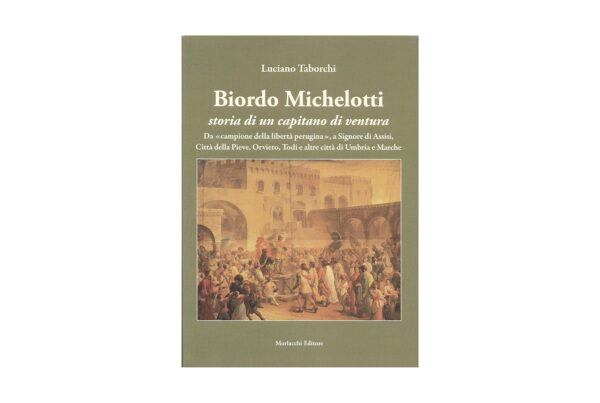di Giuliano Capecelatro
Immaginate… una villa lussuosa, con piscina, campo da tennis, prato ben curato, aiuole fiorite; adagiata su una collina che affaccia sulle scintillanti luci della metropoli. Interni arredati con fasto, quadri d’autore alle pareti. Un ricevimento. Decine di invitati, tintinnio di stoviglie, voci che si accavallano, risate in differenti tonalità. Spunta una torta gigantesca, si apre… vien fuori Mischa Auer, affermato caratterista di origine russa, simpatico ma non certo un Adone, nudo come l’aveva fatto la sua mamma.
C’era una volta Hollywood. Probabilmente c’è ancora. La gente del cinema è un prototipo umano votato a tutte le stranezze. I divi, poi… Vivono una vita al di là della vita, del tran tran delle persone comuni, che quelle ultra-vite seguono, ammirano, invidiano, sulle pagine dei rotocalchi, nelle immagini dei programmi televisivi, sull’onda delle chiacchiere, del gossip. Ingigantendo, idolatrando, divinizzando gli artefici dei loro sogni proibiti.
Ah, entrare per qualche istante in quell’Olimpo, suggerne una goccia! Sfiorare casualmente la mano di Olivia De Havilland, incrociare gli occhioni di Lauren Bacall; beccarsi un sorriso ambiguo da Humphrey Bogart; essere mandato a quel paese da David Niven.
Ecco, David Niven. C’era una volta Hollywood (Edizione Settecolori, traduzione di Claudio Gallo, 250 pagine, 26 Euro), anodina trasformazione del titolo originale (Bring on the empty horses), è opera sua. Di quel brillante attore inglese, arrivato sul set dopo un faticoso apprendistato, ma con esiti eccellenti, tra cui un Oscar. Un’immersione nel tempo che fu, tra divi che furono, nel periodo compreso tra il 1935 e gli anni Cinquanta. Dove Niven conduce il lettore con la mano ferma di quello scrittore che rivela di essere. Con la penna si era già cimentato, si cimenterà ancora.
Scrittore, appunto, non corrivo propalatore di pettegolezzi. Certo, la storia procede anche attraverso aneddoti brillanti, momenti imbarazzanti, drammatici. L’ombroso Humphrey Bogart coinvolto in una rissa, che finisce sotto il tavolo di un ristorante. Charlie Chaplin alle prese con un fastidioso imbarazzo fisiologico da risolvere alla peggio in mezzo a una folla di ammiratori. Marlene Dietrich che si faceva scarrozzare su una Cadillac, mentre Costance Bennet non concepiva altro mezzo di trasporto che la Rolls-Royce. Bennet – nome forse quasi ignoto oggi, se non ai cultori della materia – che fa sudare freddo il Niven alle prime armi con le sue bizze, i suoi ritardi, la sua avversione per Parendillo, come lei storpia la gloria italiana Luigi Pirandello, di cui non vuole recitare un testo. Salvo, dopo mille bizze e impuntature, accettare obtorto collo all’ultimo istante.
Ma quello che Niven traccia non è un collage di storie bizzarre o tristi. È uno spaccato, sapido e acuto, di quell’industria dell’immagine – la denominazione in auge sarebbe fabbrica dei sogni – che in quegli anni sta muovendo i primi passi. Ma che già esercita una notevole forza di attrazione. Su imprenditori che, fiutate le ampie possibilità di profitto, si gettano a corpo morto nell’impresa e piantano i semi del prolifico albero hollywoodiano. Su attori di teatro, cui brillano gli occhi all’idea di moltiplicare per mille la loro effigie e notorietà.
E soprattutto su una massa sterminata di spiantati, sfaccendati, ubriaconi. Attratti dal miraggio di un colpo di fortuna. Ammassati in spazi angusti in attesa di essere reclutati per una comparsata, ripagata con pochi spiccioli. Un afflusso biblico che indusse le case di produzione ad affiggere un cartello: “Non cercate di diventare un attore. Per UN attore che assumiamo MILLE ne respingiamo”. Parole al vento.
Moltissimi cominciarono dalla gavetta. Anche Niven, che integrava i magrissimi compensi con altri lavoretti, magari piacevolmente a bordo di una barca. È la ruota della fortuna del successo. Esempio illuminante. Colazione da Tiffany, con l’indimenticabile Audrey Hepburn. Nella massa di persone che danza in casa della protagonista, si può notare un ragazzotto dal naso ben pronunciato. Qualche anno dopo sarebbe diventato Dustin Hoffman, Uno su mille.
A piccole tappe Niven si fa strada nel firmamento. Frequenta nomi illustri, stringe amicizie celebri. Clark Gable, di cui traccia un lungo, elaborato e affettuoso ritratto. Lo spaccone Errol Flynn, che appena tocca le vette del successo si monta la testa, ma resta il grande amico di bisbocce e avventure galanti. Douglas Fairbanks e il suo mastino, una “minaccia bisessuale”. Se il cane si avvinghiava alle gambe di chiunque gli passasse accanto, l’attore indulgeva spesso e volentieri a scherzi innocenti e meno innocenti: dai sigari esplosivi agli insulti lanciati, attraverso un attore di sperimentata volgarità, al produttore Samuel Goldwyn.
E poi l’impenetrabile Greta Garbo, “bella svedese solitaria”, avvolta da un’aura di riservatezza, che a Niven che le chiede perché abbia abbandonato il cinema, risponde con gelida sincerità: “Avevo fatto abbastanza smorfie”. Mondo dorato su cui volteggiano come corvacci le due regine dell’indiscrezione giornalistica, Hedda e Louella, che si odiano e si danno senza tregua battaglia a colpi di scoop veri e falsi.
Un’atmosfera decadente da Grande Gatsby avvolge la moltitudine di celebrità autentiche e fittizie che abita e frequenta le ricche dimore hollywoodiane. E tocca il culmine nella tenuta e nel castello dell’editore William Randolph Hearst, quello che sarebbe diventato protagonista di Citizen Kane (Quarto potere) di Orson Welles, magnate dalla incontinente megalomania. Film che mandò Hearst su tutte le furie, soprattutto perché metteva in scena il fallimento della sua amante; Marion Davies, come attrice.
Ambiente fatuo. Personaggi che vivono per e nell’immagine. Galassia attraversata da fiumi di alcool, pasticche, pillole. stravaganze, eccessi di ogni tipo. Con una spiccata vocazione alla nudità; condizione psicologicamente significativa in soggetti chiamati di volta in volta a rivestire ruoli diversi.
Non c’è, per fortuna, la minima traccia di moralismo, la più piccola presa di distanza, che suonerebbe ipocrita, nel racconto di Niven. Lui ha fatto parte, nel bene e nel male, di quella storia. Non la rinnega e vi trasporta il lettore con una scrittura brillante, raffinata, che lascia intuire un retroterra di buone letture, con lampi di misurato humor inglese e una serie di ritratti incisivi.
Ma che c’entrano gli empty horses, letteralmente: i cavalli vuoti, con i fasti hollywoodiani? La frase fu pronunciata dal regista Michael Curtiz durante le riprese de La carica dei seicento, interpretato da Niven e Flynn. Curtiz, che avrebbe diretto Casablanca, era ungherese, parlava un inglese stentato. Per una scena gli occorrevano dei cavalli senza cavaliere; non sapendo come indicarli, ricorse a empty (vuoti), facendo sbellicare dalle risate i due attori; imbufalito, Curtiz li riempì di maleparole.
Espressione malandrina. Al di là del significato letterale, può alludere a qualcosa che, magari dietro una fulgida apparenza, risulta vuoto, inconsistente. Niven, quando la scelse per titolare il suo libro, che sarà pubblicato nel 1975, sapeva quello che voleva dire. Hollywood, le sue luci sfavillanti, la sua storia, il mito, non erano che una vana immagine. Un’ammaliante illusione. E andava accettata per quello che era.