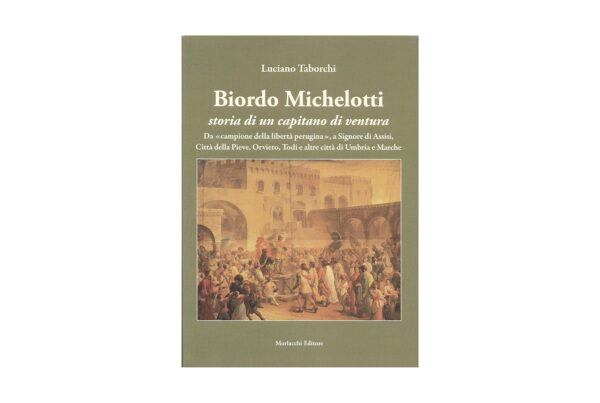di Pier Mario Fasanotti
Ci sono avvenimenti drammatici destinati a essere scolpiti nella grande muraglia del tempo, forieri di conseguenze in grado di mutare, in parte o in toto, la storia (anche quella odierna). Se ne occupa Paolo Mieli, ex direttore e de La Stampa e del Corriere della Sera, abilissimo divulgatore storico, titolare del programma tv (Rai 3) Passato e presente, è tra i giornalisti senza dubbio quelli più consultati dalla Rai e altre reti (assieme a Marcello Sorgi, Aldo Cazzullo, Federico Fubini, e l’onnipresente gruppetto di coloro che sono schierati a destra). Inoltre, con una vasta cultura alle spalle, scrive libri. In quello che ha titolato Ferite ancora aperte(sottotitolo Guerre, aggressioni e congiure) – Rizzoli, 272 pag. 18,50 euro- spazia tra epoche e personaggi, captando, e quindi descrivendo, le “ferite“, alcune delle quali sono e rimangono purulente.
Prendiamo per esempio il conflitto Russia-Ucraina. Ai tempi dell’Urss, questa vasta regione “apparteneva“ al georgiano Stalin, che pare la prediligesse (alla pari del Fuhrer) a confronto delle altre. Come tutti ricordano l’Ucraina durante la seconda guerra mondiale è stata invasa prima dalla Germania di Hitler (che mirava alla presa di Mosca) e poi dall’armata rossa che respinse i nazisti e che rase pressoché al suolo Berlino. Gli ucraini, avversi all’espansionismo sovietico, stabilirono una stretta collaborazione con la Wehrmacht, avendo come punto di forza, some sostengono certi storici, “vari e indiscutibili punti di contatto tra un certo nazionalismo integrale e violento di Kiev e le dottrine nazifasciste degli anni Venti”. Ne fecero le spese i gruppi ebraici, spogliati di tutti i loro averi. L’Ucraina nel ’91 riconquistò l’indipendenza, realizzando i sogni del nazionalista Stepan Bandera, al quale furono dedicate molte statue. Anni a dir poco turbolenti, tanto è vero che si parla di Shoah ucraina. A complicare la situazione odierna c’è da ricordare che Nikita Chruscev decise nel 1954 di “donare” la Crimea all’Ucraina. Fu lo stesso Chruscev a far costruire a Mosca il “grattacielo Ucraina”, “come più proporzionato ed elegante dei sette grattacieli staliniani dello skyline moscovita”. Senza contare la realizzazione del boulevard Ucrainsky e l’elegante decorazione di due fermate della metropolitana. Paolo Mieli non si sofferma sulla soprannominata shoah ucraina, che i russi perpetrarono con una vasta e brutale operazione che coinvolse sei milioni di persone, avendo anche come scopo quello di decapitare i vertici intellettuali e religiosi. Tra drammi e ambiguità, si è giunti al governo di Kiev, che oggi si oppone con le armi all’invasione russa, ipocritamente denominata “operazione militare”.
C’è un’altra ferita, di ampie proporzioni. I responsabili sono i gesuiti, i quali organizzarono varie missioni in America Latina, chiamate “riduzioni”. Accadde nell’arco di 150 anni, tra l’inizio del Seicento e la seconda metà del secolo successivo, in un territorio situato tra gli attuali stati del Paraguay, Argentina e Brasile. La cosiddetta evangelizzazione aveva come premessa la teoria secondo cui gli indigeni erano esseri inferiori (granitica opinione del gesuita Josè de Acosta, riferendosi all’autorità di Aristotele). La popolazione locale veniva accusata di “pratiche riprovevoli”: bigamia, omosessualità, cannibalismo. Alcuni gesuiti, che potremmo definire dissenzienti, crearono zone protette, ossia comunità autogestite sotto la direzione di uno o più autentici cristiani. Un esperimento eccezionale, tanto è vero che nacquero artigiani, operai, mercanti, musicisti, allevatori e agricoltori. L’unica strada loro preclusa fu quella del sacerdozio, cosa che suscita non pochi interrogativi. Qualche studioso parlò di “segregazione“ di molti indios in alcuni villaggi. Ci furono rivolte e stragi: i conquistadores con la tonaca presero la spada contro uomini inermi che pur si opposero, a tanta ferocia. Nel libro Padroni e schiavi, Gilberto Freyre, parla apertamente di “alterazione di tutto il ritmo della vita sociale degli indios”, aggiungendo che “il missionario è stato il grande distruttore delle culture extraeuropee, dal XVI secolo a oggi: la sua azione è stata più dissolvente di quella del laico”.
Il libro di Paolo Mieli si occupa anche delle interferenze americane in altri paesi ai tempi della guerra fredda, con episodi, a volte molto drammatici che rischiano di rimanere nel dimenticatoio. È il caso dell’Indonesia che a metà degli anni Sessanta aveva il più grande partito comunista del mondo, dopo quello russo e cinese. Gli Usa ricorse a rimedi estremi per evitare che il blocco orientale comunista si allargasse oltremisura. Washington incoraggiò tra il ’65 e il ’66 uno sterminio dei comunisti indonesiani di vasta scala: circa un milione di persone. Beffardamente gli Usa definirono l’operazione “un assoluto successo”, specificando che “nessun soldato americano morì e in patria nessuno corse pericoli”. Era la “teoria del dominio”. Dominio in cui l’Indonesia rappresentava la tessera più rilevante. Per tale operazione, il massacro, nel settembre 1965 ci fu un pretesto: un minuscolo gruppo attivo all’interno delle forze armate indonesiane rapì e giustiziò dei alti ufficiali sostenendo che stavano preparando un colpo di stato. Importante fu il ruolo di Suharto- che però si dissociò immediatamente dal loro operato- sotto il quale cadde la responsabilità di azioni “ostili” contro i comunisti. Dopo l’eccidio Suharto andò al potere instaurando una ferma dittatura filoamericana destinata a durare trent’anni. Paragonabile a questa vicenda fu quella del Brasile e di altri paesi sudamericani, Cile in primis. Alcuni studiosi parlarono esplicitamente di “diplomazia oscura” messa in atto dagli americani.
Lo storico Francis Bevin si guarda bene dal sostenere che la guerra fredda sia stata vinta dagli Stati Uniti “grazie agli omicidi di massa”. Semmai, aggiunge, la guerra fredda finì “soprattutto a causa delle contraddizioni interne del comunismo sovietico e del fatto che i suoi leader in Russia involontariamente distrussero lo stato”. Fatto sta che quel che capitò in Indonesia (si parlò della “teoria Giacarta”) precedette il disastro del Vietnam.
Paolo Mieli, nel tentativo di vivisezionare molte “fratture”, alcune delle quali interessano il nostro periodo risorgimentale, si spinge però troppo oltre. Alcuni esempi: nel ritrarre Cosimo de’ Medici che per 30 anni, in epoca anche di peste, governò Firenze “da padrino”, con l’appoggio degli Sforza di Milano, tessendo formidabili alleanze e concentrando su di sé enormi poteri finanziari. Per la città del giglio questa “frattura” non fu però foriera di periodi dittatoriali. Si pensi solo a Lorenzo de’ Medici, il grande mecenate. Lo steso vale per alcune nobildonne dell’antica Roma, definite “maledette”, come Clodia e Giulia. Il loro comportamento intrigante e licenzioso interferì sulle manovre politiche, ma non al punto da costituire una sorta di codice per il futuro di tutti gli imperatori.