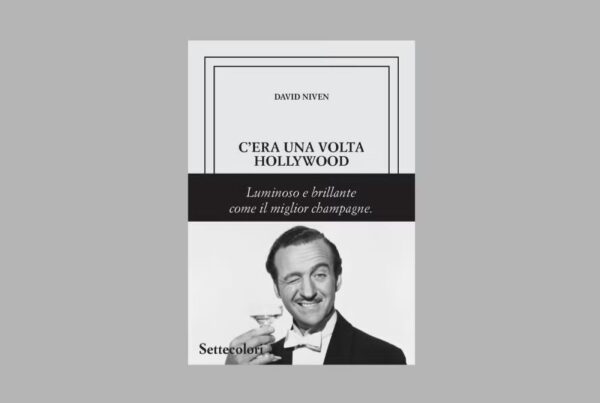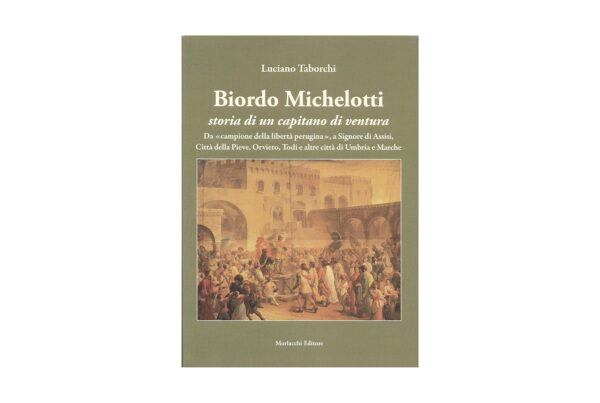di Daniela Matronola
Foto ©Mark Horrell
PAOLO MASSARI – La vacanza degli intellettuali. Pasolini, Moravia e il Circolo di Sabaudia (UTET, 2025 – pagine 192, €19)
Molti anni fa mi sono trasferita di scuola da Cassino, la mia città, a Roma: inseguivo la scrittura e gli scrittori, dunque mi parve naturale traslocare. La casa era accanto a una famosa clinica presso cui vidi poi passeggiare Rosetta Loy e Carlo Cecchi mentre all’interno spirava Cesare Garboli, e la scuola era all’altro capo della città: ci rimasi abbastanza per scoprire non solo il capolinea Anagnina della Metro A ma soprattutto L’Osteria del Curato, trattoria-ristorante gestita da un signore prodigo di racconti e di ricordi di Cinecittà: “Sa dove si è seduta lei?”, mi fece un giorno che andai lì a pranzo con due colleghe, “Lei è seduta dove si sedeva sempre Alberto Moravia”. Quel segno m’illuminò istantaneamente, anche se non mi misi a dirgli che ero in una fase molto intensa di relazione col mondo della scrittura e degli scrittori. Parto da questo piccolo fatto, inesistente a ben guardare, in apparenza personale, per evocare subito il mondo che affiora dal libro targato Utet pubblicato da poco da Paolo Massari, più che altro legato a un luogo, Sabaudia, e a un fatto di costume ma anche culturale, le vacanze degli intellettuali, acquartierati lì fin dagli anni Sessanta. E Moravia è uno dei primi tra i nostri grandi scrittori, con Dacia Maraini e l’inseparabile Pier Paolo Pasolini, ad averla scelta per le sue dune, per la sua aria, austera e razionalista, per la sua classe rétro non sfarzosa, non inutilmente lussureggiante.
Sabaudia la spartana, si potrebbe dire, nata con vocazione agricola: non c’è una sola fonte che non conclami questo dato. Altro che città turistica o “marina” del Tirreno. Certo essa è in posizione panoramica assai notevole, ma non è una “marina” perché non ha l’accesso al mare, da cui è divisa dal lago, parola di Antonio Pennacchi.
Una storia urbanistica, fin dalla recente fondazione, interessante e controversa.
Una città fascista, come Latina (Littoria), legata alla bonifica dell’Agro Pontino istruita e sorvegliata dal Duce in persona, che pretese il trasferimento di veneti e friulani, operai impiegati come schiavi in un’opera titanica per avere la meglio su un vasto territorio malarico in condizioni di vita rispetto alle quali forse solo le trincee della Grande Guerra erano state più invivibili.
Il libro di Massari, molto documentato, svolge un compito a mio avviso encomiabile.
Parte dalle memorie conservate in casa e dai testi di uno zio, Feliciano Iannella, che ha preso parte in prima persona alla fondazione di questa piccola città o piccola America – come la chiama nel suo primo docufilm del 1991 il regista Gianfranco Pannone. E crea un ponte tra il mondo di oggi e la Sabaudia degli ultimi decenni del Novecento, quando invece era un centro pieno di legami e rapporti per gli intellettuali, luogo peraltro vissuto non solo classicamente per le vacanze estive ma anche nei mesi invernali, quando il segno catatonico della cittadina era al suo apice e gli artisti godevano del famoso mare d’inverno, che era più uno sfondo e l’eco di un respiro della Natura che una sponda davvero frequentata.
Significativa l’esperienza di Bernardo Bertolucci testimoniata all’autore da Francesca Marciano, autrice di letteratura e cinema, amica del regista.
Marciano racconta a Massari che a un certo punto Bertolucci convocò Ian McEwan, il romanziere inglese, perché insieme dovevano lavorare alla trasposizione per il cinema di un romanzo di Moravia, 1934. Bertolucci aveva già portato al cinema Il conformista, dunque il progetto prometteva bene. McEwan trascorse un periodo a Sabaudia appunto per collaborare con il grande regista: era inverno, la cittadina era mogia e mogi erano i due grandi scrittori, che si spendevano in lunghe sessioni di confronto e progettazione ma il film, ci fu poco da fare, non c’era verso venisse fuori. Alla fine l’idea fu abbandonata del tutto: McEwan se ne tornò in Inghilterra e di lì a poco (1987) Bertolucci avrebbe avuto ogni riconoscimento con L’ultimo imperatore. Chissà che, osserva giustamente Massari a questo punto, le dune di Sabaudia non siano confluite suggestivamente nella sceneggiatura di Chesil Beach, sceneggiatore unico nel 2017 proprio Ian McEwan, autore del romanzo del 2007.
Sabaudia è stata anche il teatro dei pedinamenti estivi di Alain Elkann alle calcagna proprio di Alberto Moravia per il lungo libro–intervista Vita di Moravia. Viene fuori che Moravia era come sempre tellurico: a volte generoso e loquace, a volte irritabile e nervoso, al punto che quando il libro era quasi finito o meglio l’ingente materiale era stato faticosamente raccolto, Moravia avrebbe voluto mandare tutto all’aria, non credeva forse più nell’utilità che Bompiani mandasse in libreria una sua biografia, e non articolata in forma di intervista. Certamente un punto critico fu il passaggio che riguarda Pasolini, una ferita mai richiusa: Un’impresa anche del corpo, dei corpi, come spesso richiede la scrittura, ci ricorda Massari rievocando quel confronto ferragostano connotato dal calore rovente. Vita di Moravia uscì nel 1990: lo scrittore morì nello stesso anno, il 26 settembre, colto da malore sotto la doccia nella casa di Lungotevere della Vittoria – giusto in tempo, viene quasi da osservare, per sancire anche una fine altra, la fine di un mondo del quale sono rimasti ancora in pochissimi ad essere testimoni.
Un cambio di passo non solo letterario, non solo culturale, non solo intellettuale.
Un cambio di passo epocale e antropologico che coinvolge esemplarmente i luoghi.
Cancella cartografie di riferimento e avvia un processo inevitabile di storicizzazione.
Pasolini, che frequentò Sabaudia molto poco, alacre osservatore e interprete dei fieri processi di urbanizzazione seguiti anche nel dopoguerra, specie nella città di Roma, era diviso tra Sabaudia e Orte – vicino Orte acquistò una Torre presso il lago di Chia che diventò un suo studio d’artista dove poter recuperare il contatto con la Natura e starvi dentro (casa passata di proprietà da due o tre anni – doveva essere un museo).
Massari ci racconta il suo sentimento di Sabaudia come ci illustra la dedizione dovuta a un legame personale stretto del documentarista Gianfranco Pannone con Sabaudia e Latina, essendo nato a Napoli e vissuto a Roma.
Sempre in quella altalena, che sapientemente ci propone, tra la Sabaudia delle recenti origini con la sua severa architettura razionalista e la Sabaudia della intensa stagione intellettuale, l’autore ci pone forse anche l’interrogativo su quale delle due, per chi la frequenta solo o ancora ora che tutto è tramontato, sia la Sabaudia di riferimento o del cuore. È un tema questo tutto da scoprire anche in questo caso munifico e abbondante di testimonianze di prima mano – non solo rievocative, anche attuali.
Vale la pena suggerire una chiave un po’ esotica che potremmo attribuire a Sabaudia come la si è attribuita a Tangeri, in Marocco, meta nordafricana di molti intellettuali americani espatriati, incollati a quella città dalla carismatica presenza di Paul Bowles. A Sabaudia negli anni d’oro il punto di ritrovo era il bar Italia, dove Moravia amava fare l’aperitivo serale con un Campari soda.
In effetti chi viene a Sabaudia in anni più recenti ci viene per il canottaggio su quel lago di Paola che si metteva di mezzo tra chi arriva e il mare, prima che un ponte annullasse il problema. Solo adesso, finalmente, Sabaudia ha conquistato una sua legittima vocazione, riconoscibile, di città di mare – che, ci ricorda Paolo Massari, oscilla però sempre tra la stagione del Bauhaus e un intramontabile stile Moravia.