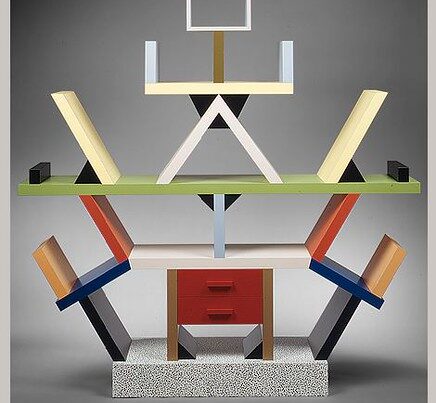di Sud
Se vi venisse voglia di leggere (o rileggere) Il conte di Montecristo, magari dopo aver visto una delle sue tante riduzioni cinematografiche o televisive, è facile che troviate tra i libri di casa una delle diciotto ristampe del libro negli “Oscar” Mondadori. Bene, compratevi un’altra edizione. Oppure, se vi va, leggete quel capolavoro di fiction negli “Oscar”, ma sapendo che vi state immergendo nell’atmosfera, nella lingua e nella politica dell’Italia di metà Ottocento.
Sì; perché quando, nel 1980, Mondadori decise di pubblicare il romanzone di Dumas padre, per risparmiare, prese una delle prime traduzioni italiane, quella pubblicata nel 1869 da Sonzogno, anonima, e quindi non soggetta a copyright, e la ristampò para para, senza neanche pagare qualcuno che la rinfrescasse un po’. La “scoperta” di Carmine Donzelli ha messo in luce una traduzione piena di arcaismi, ma soprattutto di tagli e di censure.
Un bell’esempio è nel capitolo XVI. Dantès chiede all’abate Faria perché sia in prigione, e questi, nella traduzione ottocentesca, risponde così: «Perché ho sognato nel 1807 il progetto che Napoleone ha tentato di realizzare nel 1811». La “vera” risposta è molto meno laconica: due lunghi periodi in cui Faria paragona il suo fallimento a quello di Machiavelli, alle prese con Cesare Borgia, Alessandro VI e Clemente VII, e conclude: «Decisamente l’Italia è maledetta!».
C’è tanta Italia nel Conte di Montecristo. Il barone Danglars, uno dei nemici di Dantès, è stato rapito dai briganti della campagna romana, che gli offrono da mangiare un pollastro. Dumas non lo dice, ma noi immaginiamo che il pollo sia cotto coi peperoni nel tegame di coccio, secondo l’antica ricetta della cucina romana di agosto. Chi volesse replicarla badi bene, però, di procurarsi un pollo ruspante e ben coriaceo, che non si disfaccia nella lunga cottura; e di mangiarlo tiepido.