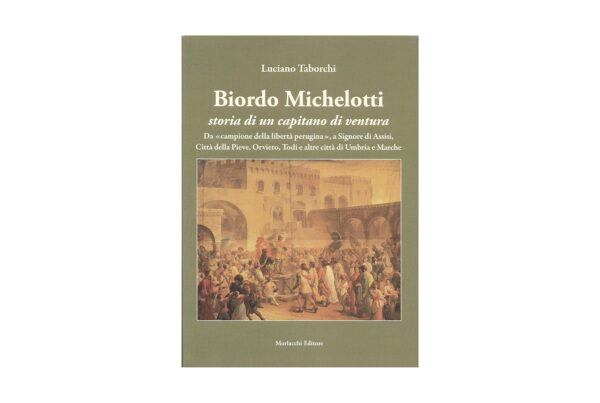di Ruggero Ranieri
Complimenti a Giuliano Giubilei per questo lungo, avvincente racconto di guerra, che merita le ottime recensioni che ha ricevuto. Si tratta di un racconto romanzato, le storie dei quattro fratelli Monteschi, che, veniamo a sapere alla fine del libro, sono il padre dell’autore e i suoi tre zii, una famiglia della piccola borghesia di Perugia, con un legame ancora vivo, a quei tempi, con il mondo della campagna. Ci si può domandare, quindi, quanto di quello che viene raccontato, e si tratta di vicende drammatiche e spesso molto amare, sia frutto di una ricostruzione aderente alla realtà e quanto sia frutto di una trasposizione romanzesca e letteraria. Sembra che si possa propendere per la prima ipotesi: l’autore, infatti, non solo si è nutrito di memorie familiari ma si è preso la briga di raccogliere testimonianze, di rintracciare documenti. Questo lo apprendiamo alla fine del libro, mentre per 400 e più pagine veniamo semplicemente calati nel susseguirsi incalzante degli eventi. Anche il non usare il nome di famiglia risponde a una strategia narrativa: dare spazio alla concatenazione delle vicende, riempendo gli inevitabili vuoti con una ricostruzione verosimile. A parte i protagonisti diretti, peraltro, gli altri personaggi che incontriamo sono tratti dalla storia, con i loro nomi reali e comprendono alcuni protagonisti dell’antifascismo perugino, da Aldo Capitini a Primo Ciabatti e Carlo Sarti.
Due parole sull’autore. Conosco Giuliano Giubilei da molti anni, siamo quasi coetanei, cresciuti insieme nella Perugia politicizzata e idealista degli anni Settanta del Novecento. Lo ho apprezzato come giornalista della carta stampata, poi come conduttore televisivo del TG3 nazionale, chiaramente di marca PD come tutta quella squadra, ma senza mai eccessi, con una buona professionalità e apertura al confronto. Più recentemente, nel 2019, ha guidato la coalizione di sinistra come candidato sindaco per il Comune di Perugia, ma lì è stato sfortunato: la città viveva ancora la sua luna di miele con il centro-destra civico rappresentato da Andrea Romizi, a cui diede una maggioranza schiacciante per il secondo mandato. (Quella stagione è finita recentemente). Non sospettavo, però, che Giubilei coltivasse anche una passione e un talento di scrittore, né che fosse disposto a uno scavo profondo, non facile e finanche doloroso sulla storia della sua famiglia, che è poi è anche la storia di noi tutti.
Cosa è che tanto colpisce in questa vicenda? La varietà delle situazioni vissute dai protagonisti. Il principale è sicuramente Andrea Monteschi, che apprendiamo essere la controfigura del padre dell’autore. Giovane fascista volontario della Milizia nella divisione XXIII marzo, parte per la Libia molto prima della entrata dell’Italia in guerra, nel settembre 1939. Combatte, circa un anno dopo, le prime battaglie agli ordini del Generale Graziani a Sidi el Barrrani e poi a Bardia, sul confine fra Libia ed Egitto e sperimenta di persona l’improvvisazione e l’avventatezza della condotta di guerra italiana. A Bardia viene preso prigioniero dalle truppe britanniche, spedito in un campo di smistamento in Egitto e, alcuni mesi dopo, nel giugno 1941 nell’India centro-settentrionale, a Bairagarh, non lontano dalla città di Bhopal. In quel gigantesco campo, dove erano prigionieri 20.000 soldati italiani, passerà ben tre anni, fino al maggio 1944. Finirà poi, sempre prigioniero, nel campo di Cowra, nell’Australia sud occidentale, impiegato in vari lavori, per ritornare a casa solo nel febbraio del 1947.
Andrea Monteschi vive, quindi, una penosa odissea nell’universo della prigionia, che coinciderà con un sofferto scavo interiore. Era partito come un fascista convinto, conquistato da uno dei temi più insidiosi della propaganda mussoliniana, quello di voler restituire all’Italia il ruolo di una grande nazione, rispettata e potente, che le precedenti classi dirigenti avrebbero offuscato e umiliato. All’insegna, insomma, di un nazionalismo insieme spirituale e aggressivo, nutrito di umori in qualche modo risorgimentali, che fece presa su molti giovani, e meno giovani. Nel corso del tempo, nella coscienza di Andrea Monteschi questo innamoramento e queste sicurezze si sgretoleranno di fronte alla constatazione della inefficienza e della vuota grandiloquenza del regime. Tra malattie, tentativi di fuga, amicizie c dissapori con i propri compagni di prigionia, specchio dei tanti frammenti d’Italia, spesso ricchi di umanità e di resilienza, conquistati, delusi e almeno in un caso, quello di Carlo Belladonna, perugino già miliziano per opportunismo, disperati e suicidi.
Ci furono, anche, gli irriducibili fascisti, che di fronte alle sconfitte e alla caduta del Duce, rifiutarono qualsiasi compromesso con i loro detentori britannici, nonostante l’intervenuto armistizio e la co-belligeranza italiana. Rinnovarono e anzi estremizzarono la loro fede e, pure nella prigionia, pretendevano di esercitarla con il manganello verso i dubbiosi e gli oppositori. Una pagina triste, ma che rifletteva quello che, intanto, stava succedendo in Italia, con le adesioni alla Repubblica di Salò. Anche Andrea Monteschi, pur con tutti i dubbi maturati, si rifiutò di firmare la dichiarazione di collaborazione che gli inglesi proposero a tutti i POW (Prisoners of war) italiani. Lo fece per coerenza, per dignità, per un rifiuto di sottostare a quello che interpretò come un ricatto. Rimase, come molti altri militari italiani, fra gli irriducibili, pur non essendolo più. E questo, certo, non gli giovò, anche se, come vedremo, l’offerta da parte degli alleati fu un mezzo inganno.
Gli altri fratelli Monteschi vivono teatri ed esperienze diverse. Il maggiore, Ugo, di sentimenti antifascisti fin dal 1940 partecipa brevemente agli scontri sul confine francese del 1940, poi viene richiamato a Roma e infine dopo l’8 settembre partecipa alla Resistenza in Umbria. Giuseppe, militare in Albania, partecipa alla dura sconfitta dell’offensiva voluta da Mussolini contro la Grecia e si trova, poi, dopo il risolutivo intervento tedesco, a presidiare un territorio albanese dove l’ostilità verso gli italiani e le azioni dei partigiani diventano sempre più insistenti. Ritornerà, per sua fortuna, a casa prima dell’8 settembre, sfuggendo così alla sorte della armate balcaniche italiane, disarmate e imprigionate dalle armate del Reich. Infine Ettore, il più giovane, partecipa alla difesa della Sicilia dallo sbarco alleato nel luglio del 1943, fatto prigioniero dagli Americani viene consegnato alle truppe francesi in Nord-Africa dove sperimenta un periodo di prigionia fra i più duri e inumani, nutrito dal rancore e risentimento dei francesi verso l’Italia. Fuggito da un campo in Algeria, ricatturato dagli inglesi, poi consegnato agli americani, collabora, da prigioniero, con lo sforzo logistico americano prima in Nord-Africa, poi nella Francia settentrionale, per rientrare in patria dopo fine della guerra, nel giugno del 1945. I genitori e la sorella intanto aspettavano, fra disperazione e speranza, il ritorno dei figli e il racconto della loro vita in quegli anni è tra i momenti più coinvolgenti del libro.
Molto quindi su cui riflettere in queste pagine: le illusioni e le delusioni, le scelte difficili, le ferite individuali e collettive che ci segnano ancora. Sull’illusione del fascismo, come vissuta da Andrea Monteschi, ho già detto, e ne trovo conferma, in modo analogo, nelle storie della mia famiglia. Quello della fascistizzazione del sentimento patrio è un tema su cui forse non abbiamo riflettuto abbastanza, presi dalla sacrosanta voglia di demonizzare il regime e le sue conseguenze. Il fascismo ha tradito sì la giovinezza di una e più generazioni, come quella dei Monteschi. Ha distrutto la patria nei suoi valori più profondi. Ma non è stato un fenomeno da operetta, né una parentesi, ma qualcosa di più profondo e, come vediamo anche oggi, con effetti e proiezioni culturali durature.
Un’osservazione vorrei fare sull’esercito italiano. Fra i prigionieri che incontriamo con Andrea e anche con Giuseppe e Ettore Monteschi, quasi tutti sono soldati o al massimo sottufficiali. Compare la figura di qualche tenente, ma i gradi più alti sono sospesi in un limbo di colpevole assenza, o di inettitudine se non di vergognosa inadempienza alle proprie responsabilità. Forse questo è un riflesso delle distanze gerarchiche che l’esercito italiano si piccava di mantenere e della scarsa fiducia che i militari avevano dei loro capi. Nell’insieme, tuttavia, mi sembra che manchi qualcosa: anche nella prigionia, i soldati non potevano che fare riferimento agli ufficiali che li comandavano e questo aspetto cruciale di ogni esperienza militare non viene fuori a sufficienza nel racconto. Dopo tutti anche i POW nei campi delegavano i rapporti con gli ufficiali britannici a loro rappresentanti, e cioè ai cosiddettiò, spesso ufficiali di complemento o anche sottufficiali accreditati presso la truppa.
Ma veniamo a uno dei temi principali del libro, su cui Giubilei, soprattutto negli ultimi capitoli, avanza ipotesi e riflessioni, e cioè la annosa e drammatica vicenda dei POWs italiani. Fino all’8 settembre del 1943 si tratta, a tutti gli degli effetti, di una catastrofe militare: ai circa 600 mila catturati e detenuti dagli Alleati, in gran parte dai britannici e in numero minore dagli americani, e spediti in varie zone del mondo (dall’India, al Sudafrica, all’Australia, all’Inghilterra, agli Stati Uniti), se ne aggiunsero altrettanti rastrellati dai tedeschi dopo l’8 settembre, quando l’esercito italiano, abbandonato senza direttive dal Re e dai suoi generali, letteralmente si dissolse. Per i POWs italiani (diversa e più grave la sorte dei cosiddetti IMI, Internati militari italiani, in mano ai tedeschi) si può parlare di scarso rispetto da parte dei detentori delle Convenzioni internazionali, in qualche caso di maltrattamenti, quasi sempre di una lunga e penosa umiliazione. Quello che avvenne dopo l’armistizio firmato nel settembre 1943 dal governo Badoglio fu un po’ diverso: si entra in una dolorosa commedia degli equivoci.
Che cosa successe e perché i soldati italiani nei campi, nonostante la resa agli Alleati e, poi, la dichiarazione di guerra alla Germania e il riconoscimento all’Italia dello status di co-belligerante, rimasero prigionieri di guerra, esattamente come prima? A chi ne va attribuita la responsabilità? Si attribuiscono colpe a Badoglio che, all’atto della firma del lungo armistizio il 29 settembre 1943 a Malta, non insistette per includervi disposizioni chiare sullo status dei prigionieri italiani in mano agli Alleati (mentre si stabilivano indicazioni chiare, peraltro del tutto virtuali, sulla riconsegna dei POW alleati dai campi italiani). Questo fu sicuramente vero, ma non sembra che il governo, pur con tutte le sue gravi colpe passate, si dimenticasse della questione; sembra piuttosto che gli Alleati, che avevano tutte le carte in mano, imponessero in qualche modo di non metterla nero su bianco. Anzi sembra chiedessero a Badoglio una dichiarazione, che egli fece pochi giorni dopo, dove si accennava a un ruolo dei militari italiani come cooperatori degli alleati in “speciali reparti di servizio” sotto il comando di “Ufficiali designati” il che, senza dirlo nettamente, prefigurava fossero ufficiali italiani. Ci fu una ingenuità nell’emettere una dichiarazione di questo tenore e Badoglio vi fu indotto dalla caramella che gli Alleati agitavano di una graduale remissione dei peccati per cui, collaborando, l’Italia avrebbe migliorato il suo status fino a diventare una possibile alleata. Le centinaia di migliaia di Pows italiani, utilmente impiegati, dovevano essere il materiale umano di questo ipotetico futuro riscatto.
In realtà gli Alleati presero la disponibilità italiana semplicemente come una concessione, e si dimenticarono di onorare qualsiasi cambiamento dello status dei POW. I comandi militari si resero conto che avevano un maledetto bisogno delle forza lavoro italiana, fornita a buon mercato (le paghe corrisposte erano di pura sopravvivenza) in vari teatri di guerra. E per impiegarla in modo sicuro e efficiente, valutarono che non si poteva che mantenerli tutti nello stato di prigionia. Le alternative sarebbero state difficili dal punto di vista diplomatico, incerte e costose. Si apriva però una contraddizione: gli italiani diventavano prigionieri di guerra appartenenti a una nazione “co-belligerante”, tanto più che, rimanendo prigionieri, sottostavano ancora alla Convenzione di Ginevra che impediva loro di collaborare allo sforzo bellico della nazione detentrice. Come uscirne? I governi alleati s’inventarono la formula del referendum individuale, e cioè si fecero firmare una dichiarazione di cooperazione da parte dei singoli prigionieri. Una maggioranza la sottoscrisse, mentre ci fu una minoranza consistente di non-cooperatori, relegati in speciali campi punitivi. Ma, come più volte e con una certa disperazione, i governi Badoglio e poi Bonomi cercarono di rappresentare, il concetto di un referendum individuale esteso a un corpo militare era una violazione delle leggi e delle tradizioni. Un corpo militare non è un corpo elettorale, tanto meno quando è in condizioni di detenzione; non è costituito da liberi cittadini e non si può, se non con il massimo arbitrio, trattarlo come tale. Tutte proteste inutili; gli Alleati avevano deciso e portarono la loro scelta fino in fondo, impiegando la manodopera dei POW per tutta la guerra con la Germania e poi anche successivamente contro il Giappone.
Cosa ci dice tutto questo? Ci dice che, nonostante promesse e belle parole, l’Italia rimaneva e veniva considerata una nazione sconfitta. E’ vero che soprattutto i diplomatici americani cercarono a più riprese una soluzione ragionevole e meno punitiva verso il governo italiano, ma si trovarono di fronte una alleanza di ferro fra il governo inglese che non aveva nessun desiderio di addolcire la pillola e gli stessi militari americani che apprezzavano e dipendevano dal lavoro degli italiani (se pure in molti casi, come per Ettore Monteschi, estesero loro un trattamento migliore e più amichevole). Così si protrasse questa lunga odissea, che mostra la non volontà di rispettare quei principi di legalità internazionale per cui pure gli alleati combatterono la guerra.
Non c’è molto da aggiungere. De Gasperi alla Conferenza di Pace nell’agosto 1946, in un fermo e nobile discorso, elencò tutto quanto la nuova Italia democratica e post-fascista aveva fatto per riscattarsi, compresi i morti fra i partigiani e fra le ricostituite unità italiane impiegate contro i tedeschi, ma la via del pieno riscatto rimaneva in salita. D’altra parte era impossibile far dimenticare a molti, per esempio alla Francia, alla Grecia, alla Jugoslavia, all’Unione Sovietica, che l’Italia di Mussolini aveva scatenato la guerra, aveva invaso e imprigionato migliaia di militari nemici e di cittadini innocenti. Nella Umbria stessa dei Monteschi furono aperti campi di prigionia e di lavoro per prigionieri slavi e per Pow alleati, dove le condizioni non erano certo commendevoli. E, dopo l’armistizio, questi prigionieri non furono liberati, ma, con qualche eccezione, consegnati o lasciati ai tedeschi che li deportarono in Germania. La guerra fu all’origine di molte prigionie e di molte giovinezze spezzate; un monito ci viene, quindi, dal libro di Giubilei per riflettere sull’amara realtà di chi siamo stati e non vogliamo mai più essere.
Riferimenti bibliografici
Elena Aga Rossi, “Il problema dei prigionieri italiani nei rapporti fra l’Italia e gli anglo-americani” in Id, , L’Italia tra le grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda, Il Mulino, Bologna, 2019
Flavio Giovanni Conti, I prigionieri italiani negli Stati Uniti, Il mulino, Bologna, 2012
Ruggero Ranieri, “La prigionia di guerra e i campi in Umbria (1940-1943)”, «Umbria Contemporanea», 2024, n. 2.