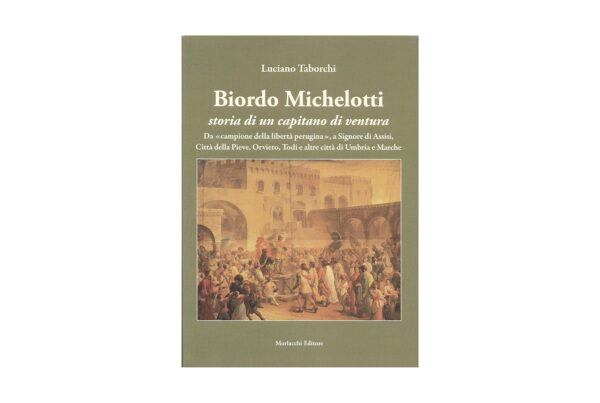di Ida Meneghello
“Volevo fare un film su Wilma Montesi. Ma più procedevo nella sceneggiatura e più incombeva la frustrazione della sua morte mai risolta. Allora ho immaginato che un’altra ragazza facesse il suo stesso percorso, ma che la sua storia avesse un esito diverso”.
Il regista Saverio Costanzo spiega così la gestazione del suo film “Finalmente l’Alba”, in concorso all’ultimo festival del cinema di Venezia e ora nelle sale.
Ma cosa c’entra con le nostre vite la storia tragica della ragazza che sognava di fare l’attrice nell’Italia del 1953 e che fu trovata morta sulla spiaggia di Capocotta?
Una pensata apparentemente bizzarra quella di Costanzo, ma non priva di senso: il caso Montesi fu il primo femminicidio con un’eco mediatica straordinaria e al regista figlio di Maurizio (cui il film è dedicato) deve essere venuta l’idea che quella storia poteva offrire lo spunto non solo per rievocare una tragedia lontana, ma anche per raccontare la soglia che divide la vita reale dalla finzione cinematografica, sogno o incubo che sia.
È l’atmosfera di quegli anni, l’Italia appena uscita dalla guerra con gli studi di Cinecittà diventati la fabbrica del cinema occidentale, che Costanzo vuole ricostruire, mescolando finzione, molte citazioni in gran parte felliniane e cronaca (alcuni personaggi evocati nel film sono gli stessi coinvolti in quel caso).
Il regista riscrive quella vicenda dando vita a una specie di alter ego di Wilma, Mimosa (impersonata dall’esordiente talentuosa Rebecca Antonaci), una ventenne che si affaccia alla vita con una criniera di capelli ricci e grandi occhi spalancati alla meraviglia, che come Wilma proviene da una famiglia della piccola borghesia romana, vive in via Tagliamento, è fidanzata con un poliziotto meridionale e sogna le star del cinema leggendone gli amori sul settimanale “Epoca”. La sua storia si svolge in un giorno e in una notte fino all’alba del giorno seguente: il giorno è quello dei provini per le comparse in un kolossal ambientato nell’antico Egitto cui partecipa sua sorella, la notte segna il passaggio di Mimosa dall’ingenuità del sogno alla consapevolezza delle scelte che la trasformano in donna. Il caso gioca, come nei film di Woody Allen, un ruolo determinante nella vicenda: l’incontro imprevedibile con la star Josephine Esperanto prima la catapulta sul set del kolossal e poi la trascina nella scoperta inquietante di ciò che sta dietro le quinte della fabbrica dei sogni, quel lato oscuro fatto di feste nelle ville, sesso e cocaina in cui era annegata la vita di Wilma. C’è una scena, all’interno della lunga sequenza della festa notturna nella villa del marchese decaduto Ugo Montagna, che secondo me racchiude il messaggio del film: quando la perfida e annoiata Josephine obbliga Mimosa (da lei presentata come una poetessa svedese) a recitare una delle sue poesie. La ragazza è paralizzata dal panico, non sa cosa fare, ammutolita inizia a piangere in silenzio comunicando il suo dolore ai presenti e suscitando in loro una compassione sconosciuta. È il riscatto delle persone semplici e ingenue capaci nonostante tutto di sfuggire alle trappole della vanità. Nel finale da favola, mentre la voce di Josephine recita i versi della poesia di Cesare Pavese “Passerò per Piazza di Spagna”, Mimosa cammina a piedi nudi in quella stessa piazza immersa nella luce rosata dell’alba, accanto a lei c’è la leonessa fuggita dal set di Cinecittà e trasformata in gatta dall’innocenza dei suoi grandi occhi. Forse metafora dei predatori che Mimosa ha saputo ammansire.